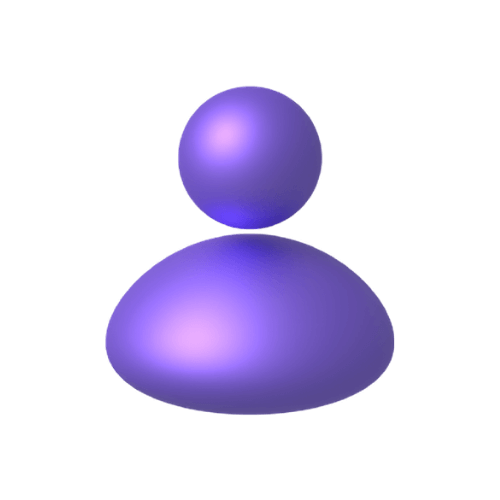Dopo Milano (LEGGI >), che ha prodotto pareri che più discordanti non si può, dove si è parlato proprio di trionfo e rinascimento come di noia mortale e agonia di tutto il sistema, atteggiamento forse sintomatico di questi tempi dove uno vale uno e quindi nulla vale nulla, non quindi propositivo e utile ma certamente libertario e divertente (varrebbe la pena fare un referendum anche su questi temi di vitale importanza), si chiude con Parigi la staffetta fashion della Spring Summer 2017. Settimana non scoppiettante ma comunque carica, come sempre anche a causa della durata romanzesca, di cose nuove e tanta hype. E soprattutto di debutti interessanti a capo di brand storici e per niente facili. Qui di seguito le cinque cose che (forse) vale la pena sapere.
1 Yves (ridaje) Saint Laurent
La questione, tra me e Hedi, è antica. Ed è quindi difficile essere oggettivi con la persona che ci ha cambiato la vita, il primo amore che non si scorda mai. Da Saint Laurent abbiamo assistito all’insediamento di Anthony Vaccarello come head designer, dopo l’abbandono non troppo tranquillo, e seguito da una coda di cause milionarie, del tanto amato Hedi. Si è respirata un’aria di restaurazione dolce, un congresso di Vienna a bassa voce. Rientra dalla finestra l’Yves del marchio, che Slimane aveva decapitato con piglio rivoluzionario. Ritorna anche il vecchio marchio, quello con le tre lettere intrecciate che era sopravvissuto solo in profumeria, e diventa tacco di décolleté anche divertenti nel loro citare l’ancien régime di un certo tomfordismo anni ’90. Il resto è un mix non troppo emozionante di basic e ricordi del de cuius come le trasparenze, gli abiti monospalla, il leopardo, giacchette e stivaletti che a cavallo della rivoluzione fecero fatturati da capogiro. Vediamo cosa attenderci da questo Metternich della moda.
2 Il femminismo di Dior?
Secondo debutto alla PFW è stato quello di Maria Grazia Chiuri da Dior dopo l’abbandono melodrammatico e (a giudicare da quello che è andato a fare dopo essersi lamentato del super lavoro per seguire due linee – Dior e la sua omonima – e della impossibilità di essere creativi quando si lavora a certi regimi, ossia seguire tutta la produzione di tutte le linee di Calvin Klein) paraculo di Raf Simons. La discussione è stata accesissima sul tema caldissimo della moda di questi anni: il femminismo. Per chi non fosse troppo addentro, Dior è l’emblema maximo di moda conservatrice. È il golem che porta avanti un’idea di donna anni 50 come nessun altro, e se da tanti questa è apprezzata esteticamente è incontestabile che qualche problema si presenti. Non si tratta naturalmente di una bieca attitudine antistorica, piuttosto di un insospettabile nazismo rosa confetto alla Bree Van De Kamp. Chiuri, per intenderci è la prima donna in assoluto a trovarsi alla guida del carrozzone che ha masticato e risputato prima di lei non solo Raf Simons, ma anche il fu John Galliano. Una sfida non facile, quindi. Lei se l’è giocata bene. E ha tirato i fili che tengono su lo show con maestria e furbizia. Si è detto molto dell’assenza di bar jacket (capo icona della maison) in sfilata, ed è vero, ma non è che proprio non ci fossero, erano solo nascoste molto bene sotto il tema della scherma (vedere uscita n. 13). Si è detto molto dell’abbandono di linee guida estetiche ormai fossilizzate. C’erano i jeans, c’erano le t-shirt con scritto We should all be feminist. C’erano gli elastici con scritto J’Adior. È vero che le cose sono cambiate, e in bene. L’impressione però è stata più quella di una collezione Dior Youth. Una seconda linea per ragazzine che possono ribellarsi ma con le mamme che comunque da lontano le tengono d’occhio. Qualcosa si muove ed è bene, ma il femminismo è un’altra cosa. Le parole sono importanti.
3 Lanvin
La terza ed ultima new entry parigina è Bouchra Jarrar da Lanvin, dopo 15 anni di Alber Elbaz, che creò l’immaginario del brand, creò l’immaginario di se stesso, e a un certo punto prese anche in giro entrambi con una memorabile ad campaign del 2011.
La Jarrar disegna una collezione di fighezza pura, senza abbandonare i tratti caratteristici di Lanvin (frase imprescindibile che ogni redattore di moda non può sottrarsi dallo scrivere, al cambio di ogni direttore creativo, per salvare capra e cavoli). E si parla proprio di Jeanne Lanvin che fu una Coco Chanel ante-litteram, di eleganze col botto da belle époque e poi anche anni 20 e 30. Ragazze à la garçonne, pantaloni palazzo, decorazioni sibaritiche in tubicini di vetro dorati e poi strass. Non mancano i volumi degli abiti monospalla tanto Elbaz che portarono in anni meno inflazionati anche a una collaborazione con H&M. Insomma sembra proprio si tratti di un’eredità felice.
4 Balenciaga che è Vetements che è Balenciaga
Ever get the feeling you’ve been cheated? Good night! chiedeva Johnny Rotten il 14 febbraio 1978, prima di congedarsi, al pubblico che a San Francisco assisteva all’ultimo concerto nella storia dei Sex Pistols, stagliando ombre sinistre su una generazione e risvegliandola in un certo senso dalla gigantesca sbronza del punk. L’anno dopo sarebbe arrivato The Great Rock’n’roll Swindle a spiegare che la rivoluzione era stata uno scherzo, non aveva senso crederci davvero, era il gioco di Malcolm McLaren. Il punk era un gioco per parlare della rivoluzione senza farla veramente e senza morire. Una rivoluzione omeopatica. Un pranzo di gala? Forse. Il punk fu una meta-rivoluzione? Non può essere un caso che sempre nel 1979 Jean François Lyotard pubblichi ‘La condizione postmoderna’ definendo il brodo tiepido di link e metalink in cui ancora sguazziamo, e dando vita agli anni 80, finalmente liberi e ricorsivi, postmoderni appunto. Demna Gvasalia con Balenciaga e Vetements sta facendo questo. Ci sta traghettando verso qualcosa di nuovo attraverso una finta rivoluzione. Cosa significano quegli abiti? Cosa raccontano? Raccontano solo del loro essere abiti e del loro essere cool. Vivono per opposizione radicale e per imitazione (degli altri, che li copiano). Se non si tratta di una nuova frontiera estetica (non lo è) di certo è qualcosa che nella comunicazione fashion e nel posizionamento non si è mai vista. A modo suo, eccitante.
5 TechnoKarl
Karl Lagerfeld è forse al momento l’unico essere umano (?) nel sistema moda che può pensare dire e fare quello che vuole. La cosa divertente è che non solo si fregia di quest’aura imperiale, ma la sfrutta tutta dall’alto dei suoi tacchi cubani e dei suoi 83 anni (per farci un’idea, ha un anno più di Mary Quant, quella che ‘ha inventato la minigonna’). Non c’è quindi niente di strano nell’ennesima sfilata cinematografica, nel setting tecnologico, come se le modelle uscissero da un server-bunker, da fantascienza distopica anni 80 e 90. A metà tra Tron e Matrix. E però poi gli abiti non c’entrano mica niente. Anzi, allegre teenager un po’ preppy, anche molto colorate e shiny. Roba da bubble bubble gum. Con il cappellino da baseball portato di traverso. Vai a sapere cosa gli passa per la testa. Vai a sapere anche nella vita vera chi è che compra l’abbigliamento Chanel, chissà dove lo tiene, chissà quando se lo mette. Probabilmente la chiave di volta è prettamente asiatica, dato tutto l’immaginario K-Pop della sfilata. Chissà se Karl ascolta il K-Pop. Chissà se è un caso che le prime due uscite della sfilata fossero due androidi con casco, uno bianco e uno e uno nero, e chissà se è proprio un caso che poi subito dopo sia apparso online un sito che fa intuire un nuovo tour dei Daft Punk, con i loro, di caschi. Probabilmente sì, probabilmente è tutto un caso, eppure rimane la pulce nell’orecchio, che tutto sia collegato, che tutto sia figlio di un disegno più grande, e che Kaiser Karl sia colui che tutto muove.
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.