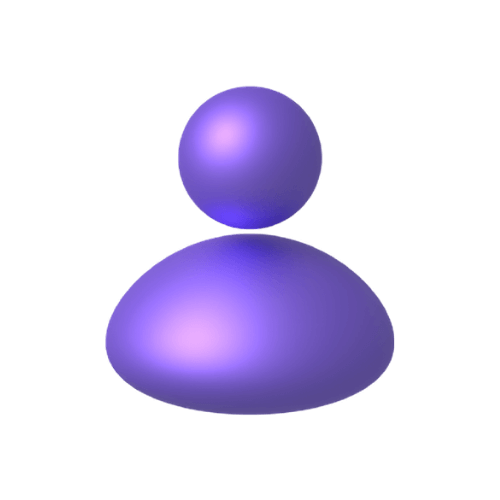La spiaggia gay di Tel Aviv si trova a fianco a quella ortodossa. A separarle una grande staccionata di legno che impedisce di vedere come fanno il bagno gli ultra-religiosi, cosa che mi interessava molto a dire il vero. Sulla spiaggia gay, invece, sembra di stare ad Ibiza, anche se il mare è più bello e più pulito. A fianco a me c’è una fauna di ragazzi bellissimi, nei loro costumi striminziti, provenienti da tutti i paesi del mondo. Il gay pride di Tel Aviv rappresenta ormai uno degli appuntamenti più importanti della comunità LGBTI globale al pari di New York, San Francisco o Rio. Per questo motivo è diventato uno dei pilastri dell’industria turistica israeliana tanto da essere promosso nel mondo dal Ministero del Turismo mentre è il Comune di Tel Aviv che lo finanzia interamente.
Oltre il dato turistico, il Pride di Tel Aviv però ha anche un significato altamente politico: si tratta dell’unico pride del Medio Oriente in una regione in cui la popolazione LGBTI non esiste. Dall’altra parte, si accusa il governo israeliano di fare operazioni di pink washing, di utilizzare, cioè, il brand arcobaleno per ripulire l’immagine di una paese che esce da decenni di conflitto. Entrambe queste visioni però sembrano semplificare eccessivamente la complessità della realtà. E’ innegabile innegabile che in Israele la comunità LGBTI ha piena cittadinanza, visibilità, diritti, questo non significa non vedere le altre problematiche che attengono i diritti umani in questa regione del mondo. Piuttosto il pride di Tel Aviv è una finestra interessante su queste complessità e contraddizioni: come sia complesso essere queer lontani dalla metropoli del mondo occidentale o come le identità LGBTI interagiscano con altre identità politiche- basate sull’etnia, la classe sociale, la religione-in una prospettiva intersezionale creando diseguaglianze e privilegi.

Intanto una drag queen, con la fisicità di un trattore Iveco e il trucco sbavato dal caldo tropicale, balla felice una canzone di Dana International applaudita dalla folla di gente eterosessuale scesa in strada per vedere la parata. Questa è una festa dell’intera città di Tel Aviv, non della sua comunità LGBT. Una celebrazione che unisce nelle differenze un paese che sembra un caleidoscopio di contraddizioni. Israele è infatti un concentrato di diversità che si riflettono anche nella comunità gay: qui le identità non sono univoche ma multidimensionali, a tratti psichedeliche. Si può essere gay, musulmano, ebreo, cristiano, ateo. Si può essere integralista o laico. Si può essere ricco o povero. Questa complessità intersezionale è tangibile, crea grande energia ma anche tensioni dentro le varie comunità e interroga i privilegi di alcuni nei confronti di ”altri”.
In Italia la parola gay riesce a descrivere abbastanza dell’identità di una persona, in Israele sarebbe impossibile. Soprattutto quando si tratta di discriminazioni e omofobia. Come mi dice Yael Doron, attivista lesbica e direttrice di Beit Dror, una casa rifugio per la gioventù LGBTI in pericolo, il rischio di essere cacciato di casa perché gay dipende molto dalla comunità etnico-religiosa o dalla classe sociale da cui si proviene: la maggior parte dei suoi ragazzi scappano infatti da famiglie musulmane estremiste o di ebrei ultraortodossi. Yael e i suoi volontari fanno un lavoro straordinario per i giovani transgender e gay che si trovano letteralmente in mezzo ad una strada. Un lavoro che, va detto chiaramente, vale mille pride. Lo fanno in una casina alla periferia di Tel Aviv, affittata con i soldi del ministero del welfare, in un quartiere popolare lontano dalla magnificenza dei grattacieli. Qui le differenze si appiattiscono: giovani LGBTI ebrei, musulmani, cristiani, vivono insieme in armonia e fratellanza. Allora penso come sarebbe bello se un giorno questa area del mondo potesse somigliare a Beit Dror. Poi incontro Eli, un ragazzo queer di diciotto anni che ha avuto una fase transgender durante l’adolescenza. Eli ha i capelli tinti biondo platino e mi mostra orgoglioso una foto che lo ritrae vestito da donna. La storia di Eli è durissima come la storia di qualsiasi giovane LGBTI cacciato via dai propri genitori. Talmente dura che fatico a porgli delle domande. Penso costantemente alla mia storia, con una famiglia liberale che invece mi ha sempre sostenuto e con una madre che mi organizzava imbarazzanti blind date con chiunque pur di farmi accasare. Non so perché ma di fronte a Eli mi sento in colpa. Ne parlo con Yael, lei mi dice che semplicemente sono stato più “fortunato”. Non sono sicuro che ‘fortuna’ sia il termine giusto, negli anni ne ho visto tanti di ragazzi come Eli abbandonati, cacciati e umiliati. Credo allora sia più corretto parlare di privilegio. Il privilegio di nascere in una famiglia pronta ad amarti e rispettarti per quello che sei, il privilegio di nascere bianco, ricco, dalla parte giusta del mondo, oppure in un paese democratico che non ti vede come un pericolo. Privilegi su cui noi gay occidentali riflettiamo troppo poco, tutti indaffarati a discutere di discriminazioni nei confronti della nostra comunità e mai delle differenze all’interno di essa.

Al pride rivedo Eli che ride e scherza con i suoi amici queer, sembra felice. Indossa una maglietta nera a retina su dei leggins neri lucidi e attillatissimi. Tiene per mano un ragazzo. E allora capisco che paradossalmente anche lui è un privilegiato se paragonato ad un suo coetaneo gay che nasce a Gaza o Mosul. Così il Pride di Tel Aviv ci ricorda il valore delle nostre libertà, già acquisite e ancora da conquistare. Ci ricorda che le lotte non finiscono con i diritti borghesi, ma continuano sui nostri corpi e sulle nostre identità, sulla nostra stessa esistenza che costantemente nel mondo viene attaccata, negata o messa in pericolo. Avere il matrimonio gay in Europa non ci può fare chiudere gli occhi di fronte a quello che accade nel resto del mondo.
Finalmente guardo con occhio diverso la folla di uomini oliati che ballano sulla base di musica tecno dell’Eurovision, le meravigliose regine transessuali che sfilano sui tacchi a spillo seguite da orde di uomini etero arrapati un po’ come al Gay Village di Roma, le lesbiche butch che sembrano vestite per andare a lavorare in miniera con gli anfibi di pelle nonostante i quaranta gradi. Questa libertà di esistere, di essere frivoli, di essere felici, di essere come ci pare, non è una colpa né un fatto scontato ma la base del nostro orgoglio. Un orgoglio che Tel Aviv non ha paura di celebrare.
Foto: Tel Aviv Gay Pride Facebook
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.