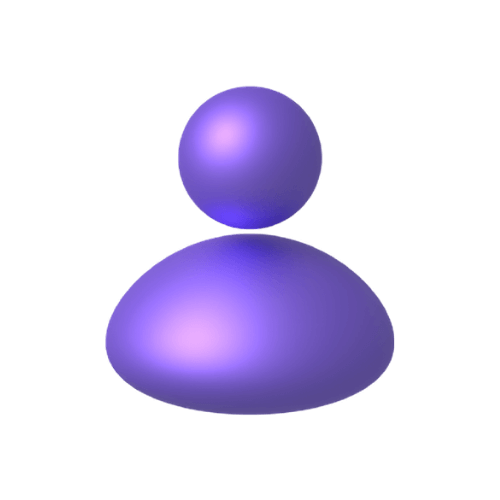In tempi di micro sensi di colpa e interminabili autoaccuse per non essere troppo efficienti nella raccolta differenziata; per lasciare il rubinetto aperto quel secondo in più; per non aver acquistato quel cappottino faux-fur… Ecco, in questi tempi di sensibilità individuali da esasperare e spremere a scopi di lucro, aziende, politici, attivisti e media – con scaltrezza e furbizia – si mascherano da Henry D. Thoreau di noi scemi e recitano il loro Greenwashing, ovvero vita ipocrita nella mia torre d’avorio (titolo sfacciatamente ispirato a questo capolavoro).
Il termine Greenwashing risale alla seconda metà del secolo scorso. È stato introdotto per la prima volta nel 1986 quando l’ambientalista statunitense Jay Westerveld denunciò un’ipocrita campagna anti-spreco di una catena alberghiera americana.
La Commissione europea ha definito la pratica del greenwashing come “l’appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un’immagine verde (…) tutte le forme di pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori concernenti gli attributi ambientali dei prodotti o servizi”.
“A seconda delle circostanze, tale pratica può comprendere tutti i tipi di affermazioni, informazioni, simboli, loghi, elementi grafici e marchi, nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull’imballaggio, sull’etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti Internet), da qualsiasi organizzazione che si qualifichi come ‘professionista’ e ponga in essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori”.
Il Greenwashing – in poche parole – è uno specchietto per le allodole, una tecnica di marketing adoperata dalle aziende, che tramite statement, campagne pubblicitarie o etichette dichiarano un rispetto per l’ambiente che non corrisponde alle loro realtà produttive o di distribuzione.
Negli ultimi quindici anni, nei quali a essere in vendita non sono solo gli oggetti, ma anche le persone e i loro pensierini da 15 secondi (soprattutto ora che tutto è pixel e sempre meno è carne), il greenwashing investe davvero tutti e ogni giorno ci troviamo invasi da consigli o delucidazioni su come sprecare in meno, su quanto stiamo distruggendo tutto quello che ci capita a tiro e sul nostro respiro che è diventato di per sé un danno irreparabile. Tutto, ovviamente, in compagnia dei soliti #ad o #gifted, così che l’aziendina di turno ringrazia e il conto in banca aumenta.
Da una parte, quindi, ci sono le politiche green e le campagne delle aziende che puntano alla colpevolizzazione del singolo, così da spingere all’acquisto dei loro prodotti per redimere i peccati; dall’altra gli influencer che vendono la propria faccia per convincerci che stiamo andando nella direzione sbagliata e che per scusarci riguardo la nostra oscena presenza sul pianeta Terra, bisogna seguire i loro consigli fai da te e comprare l’ultimo detergente per il viso libero da siliconi e con flacone plastic-free – tutto deve essere free da qualcosa, sennò il convincimento non regge – mentre le loro dispense pullulano di creme della griffe storica francese a cui non importa alcunché di essere qualcosa-free, tanto le basta il nome per vendere.
Attenzione; non voglio legittimare i comportamenti errati dei singoli, tutt’altro. Ma sia mai che qualcuno parli di chi ha in mano il potere economico o politico di cambiare le cose in maniera definitiva. No, è sempre la solita casalinga di Voghera, lei, perfida stronza che al supermercato chiede doppio sacchetto perché a un passo dall’uscita le si è già squarciato. Thunberg altro che a Glasgow, per risolvere i problemi devi scendere nel pavese e combattere la casalinga sprecona.

Una dichiarazione molto intelligente (perché veritiera, cosa rara in questa epoca di tutto-washing) l’ho sentita da Miuccia Prada, al termine di una sfilata di poche stagioni fa. Si sa, la moda è un campo minato per quanto riguarda la sostenibilità. La Signora, alla domanda riguardo cosa Prada stesse facendo per opporsi alla sovrapproduzione e (anche lì) essere free da qualsiasi cosa (magari anche dalla creatività?) rispose – vado a ricordo – “Ho cercato di fare meno, ma la moda tende a scapparti di mano”.
Ed è così. Per la moda come tutti gli altri campi. Finché saremo inseriti in un sistema, che per essere retto, ci chiede di produrre il più possibile, di consumere il più possibile, di acquistare il più possibile – bisogna dirlo e ribadirlo ancora e ancora – non potremo mai essere green, tutto-free, allegri e felici in compagnia di Madre Terra. Produrre vuol dire consumare risorse, consumare risorse vuol dire sprecare, sprecare vuol dire inquinare. E soprattutto, se vogliamo continuare ad acquistare a prezzi risibili, dobbiamo fare i conti col fatto che in questo sistema, se costa poco, avvelena di più l’ambiente, o perché fatto con materiali economici ma super inquinanti, o perché prodotto in condizioni paragonabili alla schiavitù.
Il tema dovrebbe essere trattato in maniera adeguata, e forse non basterebbero dieci saggi. Sicuramente a risolverlo non sarò io, così come non sarà la casalinga di Voghera, ma probabilmente nemmeno l’azienda onesta. Forse ormai è un cortocircuito da cui è impossibile uscire. La fine è nota, citando fuori contesto un romanzo meraviglioso. A noi non spetta altro che sederci in riva al fiume e essere bombardati quotidianamente da green-questo e free-quest’altro.
in copertina foto https://cleanbodiesofwater.org/
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.