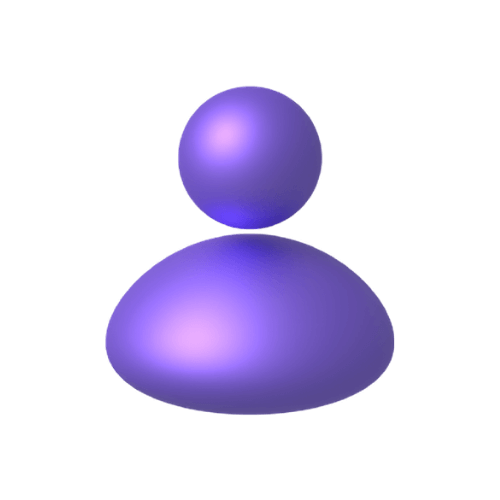C’era una volta, tanto tempo fa, in un regno molto molto lontano, una dolce fanciulla che passava le sue giornate a ballare e cantare come un’idiota nel suo castello.
Non importava quanto sole ci fosse, o quanto piovesse, grandinasse, se ci fosse il terremoto, lo tsunami o l’uragano, perché lei trovava sempre il modo di divertirsi. Il suo nome era, ovviamente, Gaia.
Aveva inoltre tantissimi amici che le volevano bene dal profondo del cuore e che lei ricambiava allo stesso modo.
Quando non c’erano, Gaia ne approfittava per ridere e scherzare con i suoi animali, i fedeli mobili semoventi e le statue magiche sparse lungo le immense stanze e gli infiniti corridoi del suo palazzo incantato.
Un bel giorno, mentre la principessa coglieva primule nei giardini reali discorrendo con un lurido lombrico che passava di lì delle proprietà dei fiori, vide arrivare verso di lei una delle simpatiche guardie con la sua buffa uniforme viola e verde: i colori del regno. Il soldato riusciva addirittura a correre, notò la donzella, nonostante si portasse dietro l’inseparabile lancia d’argento – in dotazione a tutti membri dell’unità- dodici pugnali d’avorio levigato, una spada di cristallo nero come la notte con l’impugnatura dell’ebano più pregiato, un mitra d’oro massiccio con riserva di proiettili e un paio di bombe a mano con la fodera in pelle di coccodrillo del Nilo, per essere sempre pronti ad ogni evenienza, che fosse una guerra nucleare, un’invasione aliena o l’improvvisa visita di cortesia degli ambasciatori dei regni circostanti.
Ad ogni modo, quando finalmente la guardia raggiunse la principessa, era stranamente trafelato, e Gaia provò tanta tenerezza nel vedere come il respiro affannato dell’uomo creasse delle piccole nuvolette di vapore e sorrise, standosene lì ferma col suo vestito di velluto e seta rosa e il suo cappello a falda larga ricoperto di fiori profumati e legato al viso da una leggerissima fusciacca di tulle. Quando il soldato riprese fiato, si ricompose subito e, con una voce che non tradiva assolutamente la fatica, declamò:
“Vostra altezza, giungo da voi per comunicarvi che le loro maestà desiderano conferire con voi presso la sala del trono quanto prima!”
“Ditegli che li raggiungerò in un battibaleno, mia fedele guardia” rispose la fanciulla mostrando il suo splendido sorriso, così radioso da mettere in imbarazzo il soldato che, senza comunque dissimulare nulla, com’era arrivato se ne andò.
Gaia era davvero felice di poter parlare con i suoi genitori, come di qualunque altra cosa, così si congedò dal lombrico e si avviò alla volta del palazzo, saltellando allegramente e gettando petali di rosa lungo la strada da un delizioso cestino di vimini adornato con un lussuoso nastro di raso, fermandosi soltanto due minuti nella serra per raccogliere alcune fresche e invitanti albicocche.
Quando giunse all’enorme portone della sala del trono, si voltò e vide che i petali che stava disseminando già non c’erano più. Capì subito che era opera dei servitori i quali, celermente e bestemmiando nelle loro lingue d’origine, svolgevano il proprio lavoro. Sorrise tra sé e sé, pensando a quanto era fortunata e felice e sentendosi, incredibile ma vero, un po’ sciocca per questo. Entrò nel gigantesco salone sempre a passo di danza e si fermò solo quando giunse al cospetto dei genitori, facendo un piccolo e grazioso inchino. I due monarchi si ersero in tutta la loro statura dai loro troni tempestati di smeraldi e ametiste, mostrando i loro magnifici e pregiatissimi abiti, e le andarono incontro mantenendo un contegno solenne, sebbene sorridessero di fronte al frutto del loro grande amore. Fu suo padre, alto, bello e fiero, a prendere la parola per primo, e disse:
“Mia cara Gaia, il giorno della tua nascita è stato con certezza il più felice non solo per me e tua madre, ma per tutto il regno!” Perché da quel momento la feroce carestia che si era abbattuta sul popolo cessò di esistere per sempre, come se un accecante raggio di luce avesse squarciato le tenebre che ci avvolgevano, e tu sei stata venerata come portatrice di pace e prosperità, grazie al dono che la natura ti ha fatto.” La principessa arrossì di un pudore verginale a quelle parole, che la colmarono altresì di benessere e gioia.
Sua madre continuò poi dicendo:
“Mia piccola, mia rilucente goccia di rugiada mattutina, il tuo sorriso e la tua vitalità sono sempre stati un faro, un punto di riferimento per tutti, e hanno potuto rendere felici persino le vedove più tristi e sconsolate”. “Un prodigio, un miracolo! Io e tuo padre siamo sempre stati orgogliosi di te, e soprattutto estremamente fortunati ad averti qui con noi ogni giorno per questi splendidi e impareggiabili e indimenticabili diciotto anni”.
Gaia era al limite della sua contentezza, al punto che la commozione prese il sopravvento e alcune lacrime, si fecero strada attraverso quei dolcissimi occhi blu, per poi rigare lentamente le innocenti gote. Ma fu soltanto un attimo, poi subito regalò un nuovo fulgido sorriso, ansiosa di sapere cosa potessero arrivare a dirle i suoi amati genitori dopo tutte quelle parole meravigliose. Fu a quel punto che la Regina si ammutolì e assunse un’espressione che alla principessa risultò indecifrabile. Stava per domandarne il motivo quando il Re riprese il discorso dicendo:
“… Ma ormai hai raggiunto l’età adulta, quindi sei pregata di fare i bagagli e sloggiare il prima possibile. Daremo la tua stanza al gatto di corte”.
Gaia era incredula, senza parole dopo l’amaro boccone servitole tanto aspramente.
“E perché mai, padre?” riuscì infine a dire, singhiozzando notevolmente.
“Non disperare, mio delicato fiocco di neve. Tutti nel nostro reame alla tua età devono andare via dalla propria casa, è la tradizione e va rispettata, da te in primis che devi essere d’esempio per i tuoi devoti sudditi”.
“Ma io amo stare qui, padre mio!” esclamò la ragazza, dicendo addio ad ogni riguardo “Voi mi manchereste moltissimo…come farei da sola? Non lo sono mai stata, non saprei nemmeno da dove iniziare!”
Il sovrano la guardò con un moto di compassione e dolcemente le spiegò:
“Oh, mio prelibato tortellino al ragù, tu sei pur sempre una principessa. Avrai una dote con te dalla quale potrai partire. Per il resto, arrangiati”. Detto ciò, la congedò.
Una volta tornata nella sua camera, la giovane pianse tutte le sue lacrime, che furono davvero moltissime perché mai prima d’ora aveva pianto in tutta la sua vita, da sempre costellata di sorrisi, amore e serenità. Poi si addormentò senza nemmeno struccarsi, o quantomeno togliere le sbavature del rimmel dal viso.
Il mattino dopo, quando si ridestò, aveva in sé una nuova determinazione. Pensava che mai prima d’ora si fosse lasciata abbattere e che ancora una volta doveva trovare i lati positivi della situazione, non doveva arrendersi proprio alla prima difficoltà. Così, mentre si spazzolava i lunghi capelli biondi e lisci davanti allo specchio del suo mobile da toeletta, il quale nel frattempo le faceva la pedicure, cominciò ad immaginare le mille avventure che
avrebbe vissuto grazie a quell’opportunità che tanto astiosamente aveva giudicato. Avrebbe visitato posti esotici, assistito ad intrepidi duelli e magari sposato un principe misterioso, pensiero questo che le provocò inevitabilmente l’imbarazzo di una creatura ancora casta e illibata come lei.
Fu così che la sua ansia si trasformò in impazienza. Corse nel suo guardaroba e con l’aiuto dei ratti di fogna, che tante volte le erano stati accanto nei momenti difficili, preparò le sue trentaquattro valigie e la mattina seguente tutto fu pronto per la partenza.
Quel giorno il cielo era terso e sereno, e Gaia era in piedi con lo sguardo verso l’alto proteggendosi con la mano dal riverbero del sole. Trasformò il pianto che le saliva agli occhi nel suo ampio sorriso, salì sulla sua carrozza a forma di carciofo, trainata da candidi unicorni alati con la chioma color acquamarina, e partì alla scoperta del mondo. Decollarono subito, e la principessa non poté trattenersi dal lanciare un’ultima occhiata al castello dove aveva sempre vissuto: si sporse dal finestrino e salutò con un debole gesto della mano tutti i suoi amici, i ratti, i mobili fatati e le statue magiche, tutti riuniti sulla torre più alta per l’occasione.
Visse incredibili avventure attorno al globo: andò a pesca di stelle nelle galassie più remote, nuotò con sveltezza insieme alle sirene dell’Atlantico, volteggiò senza veli – ma timidamente – in groppa ai dragoni cinesi, si armò di paletto e proiettili d’argento per cacciare vampiri e lupi mannari nell’Europa dell’est, fu ospite della comunità più popolata di fatine in Irlanda e addirittura tentò di sconfiggere i mulini a vento olandesi. Ogni tanto le capitavano momenti di sconforto, ma c’erano sempre un nuovo viaggio e una nuova terra ad attenderla.
Un giorno, mentre passeggiava su un prato quieto e soffice chiacchierando con un giovane zebù, vide l’arcobaleno e decise che voleva recuperare il pentolone pieno di sfavillanti monete d’oro, che notoriamente i lepricauni lasciavano alla fine dell’arco. Cominciò a correre in preda alla frenesia, gettando al vento tutte le gardenie che aveva raccolto come fossero coriandoli e lasciando ondeggiare col vento la lunga gonna di organza blu. Quando giunse in vista della fine dell’arcobaleno e del calderone traboccante d’oro, notò che c’era anche qualcun altro lì: una figura eterea, avvolta da un alone di luce argentea che pareva provenire dal suo corpo. Quando gli fu abbastanza vicina, costatò che la sua prima impressione non era sbagliata: si trattava di un elfo. Gaia si bloccò. Mai in vita sua aveva visto tanta bellezza: la sua carnagione era leggermente abbronzata, i capelli corvini erano raccolti in una coda, ma con alcune ciocche ribelli che ricadevano sulla fronte imperlata lievemente di sudore, sfiorando gli occhi, verdi come la profondità di una foresta. Quando lui si accorse di lei, sussultò impercettibilmente: rimase folgorato dalla visione della fanciulla e subito la desiderò. Passo dopo passo erano sempre più vicini, e quando ormai mancavano pochi centimetri per toccarsi lei sussurrò:
“Il mio nome è Gaia, e sono la principessa di un regno molto lontano da qui, in viaggio da sola per scoprire le meraviglie del mondo.” e lo scrutò attentamente negli occhi, con la sensazione di perdersi nella vegetazione lussureggiante. Lui, dopo qualche secondo, parlò con una voce calda ma armoniosa e musicale, coerente alle leggende sul suo popolo:
“lo invece sono Caleb, provengo dalla Foresta Infinita e sono il guardiano dell’oro dei lepricauni. Posso chiederti, straordinaria creatura, il motivo della tua presenza qui, alla fine dell’arcobaleno, dove io dimoro, conformemente al mio ruolo?”
La principessa era totalmente invasa da quella voce e da quelle parole, e naturalmente non voleva rivelare di essere lì proprio per il tesoro, così non seppe proferire parola, il che per lei era una cosa più unica che rara. Allora Caleb sorrise. Era il sorriso più bello che la fanciulla avesse mai visto in tutta la sua vita: non solo era luminoso e bianchissimo, ma era come se emanasse sicurezza e felicità. Solo il suo, grazie al dono di nascita che la contraddistingueva, aveva sortito questo effetto ad altri esseri viventi prima d’ora, e per questo ne fu ancora più conquistata. Al che l’elfo parlò ancora una volta:
“Vostra altezza Gaia, sono propenso a pensare che, dopo chissà quali mirabolanti imprese, vogliate provare anche quella più incredibile ed estrema.”
Gaia fu travolta da un’ondata d’immagini lussuriose che non seppe controllare, impazzì d’imbarazzo arrossendo fin sulle orecchie, e in preda alla timidezza bisbigliò:
“Non capisco a cosa possiate riferirvi…”
E lui rise. Una risata simile allo scorrere dell’acqua nei ruscelli, al fruscio del vento tra le fronde, poi la interruppe: “Intendo dire, vostra maestà, che potreste gradire salire in cima all’arcobaleno. E se lo desiderate, potrei accompagnarvi.”
La ragazza non aveva idea che fosse possibile, e fu talmente entusiasta di quella nuova prospettiva che accettò immediatamente. Lui le cinse la vita con un braccio e insieme entrarono nella scia dell’arcobaleno, che li trasportò su, sempre più su, fino al punto più alto. Il panorama era mozzafiato ma Gaia non si lasciò prendere dall’euforia e rimase saldamente aggrappata al bicipite muscoloso del guardiano temendo di cadere. Mica era scema. E all’improvviso, lui la baciò. E lei ricambiò, felice che il suo primo bacio fosse così magico e irripetibile. E sulla cima di quell’arcobaleno, Gaia provò anche per la prima volta la gioia più grande, che lei stessa in seguito si sorprese di non aver mai provato: fecero l’amore, così a lungo che lasciarono tramontare il sole e restarono ancora avvinghiati sotto le stelle, che mai erano sembrate così brillanti. E nel momento culminante, godette come una vacca. Ma così tanto e così di gusto, che finalmente aveva una buona ragione per sorridere come una deficiente tutto il tempo.
Lei ogni giorno tornava lì, ormai era innamorata e non poteva farne a meno. Il desiderio di visitare il mondo era poca cosa rispetto a Caleb, la sua voce, la sua risata, i suoi occhi e il suo… flauto magico. Ma una giovane donna come lei, così poco consapevole della vita, che mai aveva sperimentato i mali che affliggono l’umanità, abituata a regalare la sua fiducia a piene mani a tutti senza nulla chiedere in cambio, non poteva assolutamente sapere quanto Caleb fosse sadico stronzo e donnaiolo come mai nessun elfo era stato. La notte dell’Agaetì Blodren, la sacra festa degli elfi cui lei non fu invitata, lui si presentò ubriaco d’ambrosia fatata prima di sottoporsi al rito di trasfigurazione e la picchiò con tutta la sovrannaturale forse elfica di cui la natura lo aveva dotato. Le rubò tutti i tesori del regno che lei aveva con sé e fuggì nel folto della Foresta Infinita, dove mai lei avrebbe potuto ritrovarlo, lasciandola priva di sensi e sanguinante nella radura dove erano soliti incontrarsi, con la sola luce della luna a tenerle compagnia.
Si ridestò solo due giorni dopo, durante i quali aveva delirato in preda alle convulsioni, arrivando anche a parlare in aramaico come se fosse posseduta. Nel momento in cui aprì gli occhi, vide quelli neri e acquosi dello zebù e lanciò un urlo di terrore. Il suo amico cornuto tentò di rassicurarla e le spiegò che era stato proprio lui a portarla in salvo nella grotta di giada dove ora erano rifugiati. In un primo momento, Gaia non volle saperne di staccarsi dalla stalagmite a cui si era aggrappata. Fu solo dopo ore che si avvicinò titubante allo zebù, per poi crollargli addosso in un abbraccio appassionato, riuscendo soltanto a mormorare: “Grazie”, prima di scoppiare per la seconda volta nella sua vita in lacrime. E fu molto peggio della prima, perché ora a ogni movimento, sussulto e tremore, arrivava una fitta di
dolore a scuoterla ulteriormente, in ricordo della violenza subita.
Pianse di sofferenza, sì, ma anche di rabbia nei confronti della bestia che le aveva fatto questo, dei suoi genitori che l’avevano abbandonata a se stessa, dei suoi amici che non erano con lei per sostenerla – a parte lo zebù ovviamente – e nei suoi stessi confronti, perché la sua ingenuità era stata tale da permettere che tutto ciò accadesse.
Passavano i giorni, ma la fanciulla non trovava pace. A nulla servivano le parole dolci del ruminante, che mai la lasciava sola, né i regali della natura che prima invece apprezzava spontaneamente, né le scarpe di Jimmy Choo che aveva trovato nel tronco di un albero cavo. Così, ormai quasi senza più forze per andare avanti, una notte di tempesta, mentre lo zebù giaceva sul suo letto di foglie di palma ancora profondamente addormentato, Gaia lasciò la grotta raccogliendo le sue ultime energie – e soprattutto portandosi dietro le Jimmy Choo – in punta di piedi, per non svegliare il suo compagno. Decise di tornare a casa sua, al calduccio del suo letto. Così, camminò stancamente per tutta la notte sotto la pioggia
incessante.
Al mattino, il sole tornò a risplendere.
E con esso apparve l’arcobaleno.
Si fermò a contemplarlo, pervasa dai ricordi del dolce amore che aveva provato e che, forse, in qualche modo provava ancora, ma era quasi come se fossero ovattati e lontani. Non voleva. Desiderò riviverli ancora, di vederli nitidi, di tornare a quando avevano senso, quantomeno per ritrovare un po’ di quella felicità che era parte integrante di lei un tempo. Un tempo che ormai le apparve remoto e irraggiungibile. Capì che non poteva semplicemente tornare a casa, sebbene dentro di sé fosse tanta, troppa, la voglia di sentirsi ancora quella principessa innocente, che si meravigliava di ogni minimo e anche futile dettaglio. Così corse disperatamente verso l’arcobaleno, colma di nuove forze. Corse e corse come una povera pazza, finché non raggiunse il calderone vuoto, e dunque ancora privo di guardiano. Si lanciò nella scia colorata e umida dell’arcobaleno e si fece trasportare fino in cima, sicura di rivivere parte di quella felicità perduta. Non appena fu lì, però, la prima cosa che pensò fu:
“Non mi sento felice.”
Il dolore, anzi, tornò a colpirla ancora più forte. E così, sentì dentro di sé che non sarebbe servito a nulla tornare indietro, né nel tempo, né in quel mondo, o in quel regno che non avrebbe mai più sentito suo e che per questo non sarebbe stata mai capace di governare. Perché ormai non sarebbe stata felice mai più. Perché il suo dono era andato perduto per sempre. In fondo nemmeno tentare ne sarebbe valsa la pena: se non ci riusciva ora che ne era tanto sicura, come avrebbe potuto in seguito? Non voleva sentirsi così mai più, non voleva mai più fallire.
Non provando più alcun timore, posò un’ultima volta lo sguardo sull’incredibile panorama che si estendeva davanti agli occhi, guardò languidamente le favolose scarpe che aveva con sé e che mai avrebbe indossato, e le gettò via. Poi, ormai libera, si aprì in un ultimo debole sorriso e si lasciò cadere. Proprio dalla cima dell’arcobaleno, che tanto aveva significato per lei.
Per fortuna, i suoi genitori erano ancora abbastanza giovani e in salute, ebbero un altro figlio, il mondo continuò ad andare avanti e tutti ebbero la possibilità di essere felici.
PARTE 2
Non troppo tempo dopo nacque un giovane principe, colpito da una maledizione fin dalla sua nascita. Lui ebbe la sciagura di possedere il dono inverso a quello di sua sorella: non riusciva mai a sorridere e chiunque gli si avvicinasse abbastanza non poteva fare a meno di piangere e di sentirsi immensamente triste. Il suo nome era Mesto.
Contrariamente a Gaia, quindi, non aveva amici e non era in confidenza con gli incanti del castello, che pur tentando talvolta di intavolare una conversazione, finivano sempre singhiozzando senza tregua, tanto che al giovane rampollo non restava altro che fuggire coprendosi portandosi le mani al viso, i capelli al vento, trascinandosi dietro il mantello di caribù e con qualche lacrima che sfuggiva dalle fessure tra le dita, sbrilluccicando ai raggi del sole stagliati attraverso le immense vetrate del palazzo, potendo mormorare tra le labbra unicamente un “Mi dispiace”, dettato dalla vergogna che aveva di sé stesso. Anche esseri viventi più semplici, come le piante, non potevano fare a meno di afflosciarsi o marcire al suo passaggio.
Siccome anche il suo aspetto rispecchiava questa sua caratteristica, con quei capelli rifulgenti di corvina lucentezza, quegli occhi anch’essi neri come un pozzo senza fondo e la pelle candida come seta appena intessuta, fu inevitabile che tra la servitù, la corte e successivamente anche nel resto del regno, si diffondesse la convinzione che il principe fosse uno iettatore con i controfiocchi. Non era raro vedere persone camminare con trecce di peperoncini attorno al collo, o che si gettavano prontamente nell’erba alta e nei cespugli solo perché speravano di trovare un quadrifoglio o un coniglio a cui staccare una zampa. Addirittura ogni tanto le scale si chiudevano di colpo – perché incantate – perché lui non vi passasse sotto. Generalmente i gatti neri cambiavano strada incrociandolo e, inutile a dirsi, i fabbri erano specializzati nella produzione di ferri di cavallo.
Sebbene Mesto fosse abituato non solo a vedere gli altri piangere e disperarsi ma anche al gratta-gratta generale, desiderava comunque una vita normale, o almeno di poter vedere le persone che amava felici che lui fosse lì con loro. Il principe cercava di non uscire per nulla dalle sue stanze, se non era strettamente necessario, ma non poteva fare a meno di recarsi ogni tanto nel Salone Ancestrale, dove campeggiava immenso il ritratto della sorella defunta. Aveva moltissime domande che gli ronzavano per la testa, ma solo quelle, perché mosche e insetti pure erano troppo depressi per rompergli le scatole.
Un giorno decise di dar voce ai dubbi, le incertezze e la confusione che lo pervadevano.
Successe un giovedì pomeriggio, mentre disteso sul baldacchino circondato da pesanti tende di velluto nero, nella sua stanza illuminata unicamente da qualche candela sparsa, casomai qualcuno si potesse dimenticare chi ci viveva dentro. Si alzò, indossò la sua vestaglia da camera damascata, attraversò la stanza scansando il baule in castagno e oro massiccio cesellato decorato con volatili rari in bassorilievo ai piedi del talamo, arrivò di fronte agli scaffali della sua immensa libreria, tanto grande perché ricordiamo, non aveva un bel niente da fare, afferrò la campanella in porcellana ming li appoggiata e la scosse con decisione dando vita a un suono cristallino ma solenne. Dopo pochi secondi si sentirono dei passi quasi timorosi percorrere il disimpegno e subito dopo qualcuno bussò debolmente. A quel toc-toc’ appena accennato, rispose con un altrettanto flebile “Avanti”, un po’ afflitto dal dover assistere di sua volontà all’effetto della sua maledizione.
Le porte si aprirono cigolando in tono grave e il paggio entrò. Indossava una calzamaglia viola con sopra dei pantaloni a palloncino di broccato verde, una casacca dello stesso
tono smeraldo coperta di ricami ametista in stile barocco, il tutto sormontato da un ampio copricapo floscio che portava sul lato una lunghissima piuma di marabù viola. Mesto non ebbe nemmeno il tempo di guardarlo negli occhi che il giovane già era in lacrime, sebbene tentasse di mantenere il contegno che si confà alla presenza di un reale. Poi scoppiò in un pianto disperato che Mesto non sapeva assolutamente come reagire e non poté fare altro se non rimanere paralizzato di fronte alla scena.
Due ore dopo, la situazione si stava facendo decisamente esasperante: il povero servitore era rosso in viso e quasi non aveva fiato, il moccolo gli cadeva a fiumi e non si reggeva in piedi. Mesto, abbattuto e depresso come non mai, gli si accovacciò accanto e tutto d’un fiato disse:
“Di’ per favore ai miei genitori che li incontrerò appena possibile nella sala del trono.” Dopodiché si allontanò il più possibile mentre, raccogliendo le ultime forze, il messaggero fuggì come se fosse inseguito da una qualche belva feroce.
Non appena fu solo di nuovo, il principe si liberò delle sue vesti da camera e indossò la sua tenuta informale per vedere il re e la regina: stivali di pelle di drago del nord con fibbie in platino, braghe aderenti di pura lana vergine cachemire d’angora, una casacca sblusata di un lino esotico talmente puro da lasciare una scia arcobaleno al reattivo di Herzberg, il tutto adornato da un’enorme pelliccia di lupo nero con tanto di testa poggiata sulla spalla, che gli si afflosciava dietro elegantemente.
Ovviamente in testa, leggermente sbilenca, si mise la corona di rappresentanza in oro bianco a otto punte, con altrettante onici nelle fessure più grandi. La testa di lupo sulla spalla lo incoraggiò: “Non temere, vedrai che andrà tutto bene”. In fondo erano abbastanza intimi da concedersi certe confidenze, e se non subiva l’influenza della maledizione, era perché non si trattava esattamente di uno dei tanti incanti del castello, ma semplicemente di una pelliccia “venuta male”.
Mesto s’incamminò abbastanza deciso, sperando in cuor suo di non incrociare nessuno. Non poteva certo immaginare che nel corridoio subito antistante alla sala del trono erano stati posti recentemente due rami Fiore di Giada appena importati dalle Filippine, d’inestimabile valore. Fu così che girando la sua ultima curva a destra, ebbe solo il tempo di vedere due cascate di petali azzurri con pistillo blu polverizzarsi e cadere dolcemente al suolo come banale farina. Manco a dirlo si accasciò in posizione fetale piangendo angustiato.
Quando finalmente entrò nel salone rotondo contornato da colonne corinzie, si fermò sulla porta che aveva appena chiuso dietro di sé, si rivolse ai suoi genitori alzando la voce sfruttando l’acustica perfetta, e disse loro:
“Non farò un passo di più, affinché non abbiate difficoltà a parlarmi, siccome debbo discorrere con voi di molteplici argomenti. Inoltre volevo scusarmi per aver tardato qualche minuto ma… ”
“Si pasticcetto abbiamo sentito i piagnistei da femminuccia.” disse la madre inclinando la testa di lato. I monarchi effettivamente subivano solo parzialmente il voodoo che il principe potava con sé grazie alla grandezza della sala e all’estrema distanza delle due parti: non piangevano, si limitavano ad essere tristi e depressi.
“Orsù mio erede -declamò sua maestà il re – cosa volevi comunicarci?”
“Cosa è successo a mia sorella? Com’è morta?”
Se possibile i volti dei regnanti si adombrarono ancor di più e presi alla sprovvista, rimasero senza parole. Così Mesto incalzò:
“Devo capire se c’è un modo per spezzare questo orrendo maleficio che mi perseguita e forse che partendo da Gaia, dalla sua storia, sarà più semplice…se sapete qualcosa, ve ne prego…”
“Lo zebù. Ci ha detto tutto lo zebù” disse di botto la regina, che pareva parecchio frustrata.
“Mesto, mio diletto…sono certo che tua madre è solo particolarmente sensibile all’incanto che scaturisce da te…” disse il sovrano guardando la sua consorte con la coda dell’occhio e
sudando freddo:
“Ti spiegherò tutto io, anche se prima del dovuto. Devi sapere che nel nostro regno, una volta compiuti i 18 anni, i giovani devono partire per un viaggio alla ricerca del loro vero io, scoprire il loro destino, leggere dentro sé stessi, dilla un po’ come te pare. E anche tua sorella se ne andò. Ci viene insegnato a non aspettarci che i giovani ritornino, si può restare a vivere ciò che le stelle hanno scritto, così semplicemente noi continuammo la nostra vita.
Un giorno, qualche anno dopo la partenza di Gaia, le guardie ci annunciarono l’arrivo di un ospite. Si trattava di uno zebù il quale, ci dissero, voleva assolutamente parlare con noi.
Decidemmo di ascoltare cosa aveva da dirci, e soprattutto io volevo sapere come fosse fatto uno zebù, quindi si portò al nostro cospetto e ci raccontò tutto: tua sorella conobbe l’amore
in quel periodo, ma non lo riconobbe in quanto quest’ultimo, un abitante della Foresta Infinita, la inchiavicò di mazzate e le rubò tutto ciò che aveva per poi fuggire nel folto della sua foresta che, come lo stesso nome dice, è infinita e se non la si conosce è un vero labirinto. Lo zebù ci ha detto di averla curata e di averle tenuto compagnia tutto il tempo, ma una mattina lei non c’era più. Lui la cercò subito nel luogo dove lei e il bastardo si erano
incontrati perché sospettava che Gaia non l’avesse davvero superata….ma purtroppo tutto ciò che trovò fu il cadavere di tua sorella in posizione innaturale e con parecchie ossa fuori dal corpo che giaceva ai piedi dell’arcobaleno”.
Il re si fermò per dare a Mesto il tempo di smettere di vomitare. Poi aggiunse:
“Per quanto riguarda l’aspetto dello zebù…è solo una mucca con la pelle flaccida, una vera delusione. Insieme ai migliori astrologi e sciamani, comunque, abbiamo convenuto che mentre lei moriva, tu nascevi, in più c’era un’eclissi da qualche parte e Orione era in quadratura…o forse Urano…e insomma c’era questa particolarissima congiunzione astrale. Le abbiamo anche dato un nome, pensa!”
“E sarebbe?” chiese il ragazzo allontanandosi dalla pozza che aveva lasciato per terra.
“Che Merda.”
Mesto aveva bisogno di rimettere in ordine le idee, ma soprattutto di ripulirsi, al che la testa di lupo sulla sua spalla lo guardò in cagnesco e disse:
“Non ti permettere!”
Di conseguenza usò l’avambraccio, poi esclamò:
“Ora mi è tutto molto più chiaro. Partirò subito per cercare di capire meglio le vicende che hanno coinvolto la mia povera sorella fino alla sua morte, perché sono certo che se riuscissi in qualche modo a riscattar… ”
“Parti? Cioè…stai per partire?”
Esclamò la regina sobbalzando dal trono e scostandosi dal volto il velo di tulle rosa confetto “Ma è fantas…insomma …è una decisione molto importante, dovrai prepararti al meglio! Corri subito in camera a fare i bagagli, noi penseremo a tutto l’equipaggiamento che un’impresa del genere richiede. In poche ore sloggi…sarai pronto!”
Stranamente la madre di Mesto sembrava aver riacquistato un certo vigore.
In men che non si dica tutto fu pronto, con solo alcuni intoppi per la disperazione occasionale di qualche servo quando costretto all’interazione col principe che, essendo inverno, ebbe in dotazione una slitta coperta nera cromata trainata da otto orsi polari che inseguivano altrettanti caribù, per renderla più veloce.
È lapalissiano e grottescamente divertente dire che tutti furono tristi e piansero mentre erano riuniti nel cortile esterno del castello per salutare il principe, il quale cercò di congedarsi il prima possibile proprio per spirito di comprensione. Quando fu a qualche centinaio di metri di distanza, mentre ancora si asciugava le ultime lacrime con il suo fazzoletto di raso avorio, giurò di sentire come degli spari simili a fuochi d’artificio e della musica da fiera in lontananza alle sue spalle, ma non si voltò perché ancora troppo scosso dall’amara e repentina separazione.
Partire d’inverno fu una saggia decisione, perché la natura era già “morta” e così nulla sarebbe appassito mentre il principe maledetto attraversava pianure, montagne, deserti, colline. In pratica il suo viaggio proseguì in maniera decisamente noiosa, non fosse altro per gli sconnessi aneddoti e le barzellette sgangherate che il lupo sulla spalla raccontava di quando in quando.
Finalmente arrivarono all’entrata della grotta, dove lo zebù aveva poi messo radici. Lo scintillio verde delle pareti era spettacolare fin dall’esterno, ricordava molto il colore del Fiore di Giada che Mesto aveva involontariamente polverizzato. In piedi, dall’imboccatura della caverna, chiamò lo zebù a gran voce, sperando che dopo tutti quegli anni fosse ancora vivo. Una voce vecchia e stanca gli rispose da lontano:
“Chi sei? Perché resti sulla soglia?”
“Non venire verso di me o starai male! Mi chiamo Mesto, sono il fratello minore di Gaia. Sono maledetto nel modo inverso a mia sorella, porto pianto e tristezza con me, mi dispiace”.
“Mi avevano parlato di te…eri ancora un bebè quando venni nel tuo regno” si sentì rispondere e riecheggiare tutt’intorno, mentre una sagoma dalle enormi corna avanzava verso il principe.
“Credimi, so di non poter essere afflitto dagli effetti della tua maledizione, perché quando tua sorella si sfogò per ciò che le era successo, io ero lì. E credimi, quando una sorgente di felicità così potente cadere in pezzi, e quando una magia di tale portata come un dono di nascita si spezza, ha effetto tutto intorno a sé.”
Lo zebù ormai era talmente vicino da poterlo toccare. Effettivamente sembrava proprio una vacca con la pelle appesa. Mesto era sconvolto dal fatto che l’animale mantenesse un atteggiamento così tranquillo e rilassato, perché non era mai successo prima.
Ora finalmente era vicino a una soluzione: “Un evento talmente potente da scatenare una reazione inversa a quella della magia che ci ha colpiti, potrebbe quindi vanificare l’incanto! Se così fosse, sarebbe anche il motivo per cui Gaia non poteva riprendersi del tutto! E’ così?” chiese Mesto, afferrando lo zebù per il gargarozzo penzolante e scuotendolo vigorosamente.
“È la stessa conclusione che ho tratto io.” confermò il ruminante tremolando.
“I miei genitori hanno detto che hai trovato Gaia dove si era incontrata la prima volta con quest’uomo che le ha fatto del male… ma com’è morta?”
“Non lo so, altezza. In tutti questi anni non ho smesso di chiedermi se sia stato un incidente, se qualcuno l’abbia uccisa o…beh, ho pensato anche che potrebbe aver scelto lei di farlo. Ma nonostante tua sorella mi avesse parlato di lui, quando ho iniziato le mie ricerche, sembrava che nessuno avesse visto un uomo corrispondente quella descrizione. Posso dirti che si trattava di un elfo, questo è certo.”
Sconvolto, Mesto disse soltanto: “Indicami come arrivare alla radura dove trovasti Gaia tramortita e priva di sensi.”
Il mattino seguente, nuovamente solo, e riluttante a lasciare l’unico essere vivente immune alla sua presenza, si diresse verso sud, preparandosi a rovinare il clima primaverile e rigoglioso che avrebbe dovuto affrontare. I primi segni arrivarono abbastanza presto, così inevitabilmente la slitta fu abbandonata. Il giovane proseguì a piedi, lasciando una scia di
cenere grigia dietro di sé dove prima c’erano erba e fiori. Giunse alla radura proprio di notte e con la luna piena, come nello scenario descritto dallo zebù al momento del ritrovamento, e lì, ormai stanchissimo, ebbe soltanto il tempo di denudarsi per la notte, gettarsi per terra e piangere fino allo sfinimento. Si addormentò coperto soltanto dalla pelle di lupo, che gli latrava una ninna nanna.
Al risveglio il sole lo accecava, così si girò di lato. Contro ogni sua previsione, e a tre centimetri dal suo naso, c’era qualcuno che lo fissava. Mesto spalancò gli occhi e si fece subito indietro, imbarazzatissimo per le circostanze e per l’inevitabile alzabandiera mattutino. Era un giovane uomo d’incredibile bellezza, con gli occhi più verdi che si fossero mai visti, quasi fossero due gemme preziose levigate alla perfezione dal miglior artigiano della storia, e i suoi capelli arruffati e selvaggi erano color miele, e quasi ne avevano il profumo; la pelle era candida come alabastro e siccome indossava soltanto un paio di bermuda piuttosto scaciati, il suo corpo si mostrava in tutta la sua mascolinità.
‘Per non parlare di quelle fossette precazzali’ Si ritrovò a pensare Mesto in un attacco d’incontenibile lussuria.
“Aspetta ti prego! Non volevo spaventarti! Non avevo nessuna intenzione di farti del male, semplicemente non ero sicuro che stessi bene perché giacevi tutto solo, nel bel mezzo della radura… ed eri così… bello…” disse lo sconosciuto sorridendo maliziosamente.
Un momento.
“Non ci posso credere! – esclamò il principe in preda allo sgomento più totale – lo…io non avevo mai visto qualcuno che…”
Mesto aveva gli occhi comprensibilmente strabuzzati e una mano tremante davanti alla bocca, mentre le parole gli morivano in gola. Lo straniero però rimase perplesso,
non sapendo cosa stesse succedendo, e assunse un cipiglio assai confuso, al che l’altro quasi gridò:
“No, ti prego! Non smettere! Fallo ancora!” si avvicinò al nuovo venuto gattonando e trattenendo a stento attorno a sé la pelliccia di lupo, ormai sveglia e piuttosto seccata.
Poggiandogli una mano sulla guancia insistette:
“Prima d’ora nella mia vita ho conosciuto soltanto tristezza, depressione, decadenza e lacrime perché sono nato destinato a questo…perciò ora sono io che non voglio spaventarti chiedendoti di continuare a sorridere finché mi trovo qui con te, perché mai una volta prima d’ora avevo potuto goderne in mia presenza. Sorridimi”.
“Niente mi sembra più facile mentre ti guardo, credimi.” rivelò il forestiero.
Pur non avendo termini di paragone, Mesto sentì che quello era il sorriso più meraviglioso
che potesse esistere: una sequenza di perle perfette e bianchissime tra due labbra sottili e quegli occhi di smeraldo dalle lunghe ciglia socchiusi e sinceramente felici.
“Come ti chiami?”
“Mesto…e tu?”
“Puoi chiamarmi Makàr.”
Si baciarono a lungo e appassionatamente, le loro bocche rimasero avvinghiate l’una all’altra. La lingua di Makàr era dolcemente invadente e morbida – a differenza di qualcos’altro in basso ben più duro – e le sue mani esploravano il corpo del principe in ogni anfratto. E ricordiamo che se non fosse stato per il mantello di lupo, che in quel momento tra l’altro era piuttosto in difficoltà, essendo generalmente verecondo, il giovane era nudo. Furbo Makàr.
Il sole iniziò a tramontare, dipingendo di rosso tutto il paesaggio e allungando le ombre dei due amanti, che si staccarono dopo un tempo irragionevolmente lungo. E fu allora che accadde: tutto ciò che Mesto stava provando doveva manifestarsi, così sentì che le labbra gli si stiravano in modo netto e sincero, lasciando intravedere i denti, e gli occhi fecero lo stesso, rendendo lo sguardo così profondo da regalare un’immensa carica espressiva e comunicativa a tutto il viso. Stava sorridendo. Per la prima volta nella sua vita, seppur commosso e in reale difficoltà, il principe maledetto finalmente sorrideva.
Corsero alla luce aranciata del sole calante attraverso la pianura, e l’erba restava erba finché erano insieme, gli uccellini cantavano, i fiori si potevano annusare senza che appassissero. La commozione e la gioia di Mesto erano indescrivibili. Tenendosi per mano, giunsero ai margini di una foresta i cui alberi sembravano secolari, così verdi e così alti che il principe nemmeno era certo che nel suo regno potessero concepirne l’esistenza.
“Entra con me, Mesto, resta con me.”
“Che posto è questo?”
“La Foresta Infinita.”
Un’ombra passò sul viso del giovane principe, ricordandosi di Gaia e di ciò che le era stato fatto proprio da un elfo proveniente da lì. Forse Makàr avrebbe potuto addirittura aiutarlo a scoprire qualcosa, forse era una specie di segno. Ma il solo pensare a queste cose, fece tornare in mente a Mesto la malinconia, la tristezza, la solitudine, l’alienazione. E decise che ora che aveva assaggiato la vita, la contentezza, non se ne sarebbe privato, non ancora! Avrebbe rimandato la sua missione il più a lungo possibile, visto che ormai la maledizione sembrava poter essere spezzata grazie a questo nuovo sentimento che con tanta semplicità riusciva a renderlo felice, normale. Così disse soltanto:
“Sì, andiamo.”
Così passarono giorni e giorni di pura scoperta, sorrisi instancabili, potersi arrampicare sugli alberi e sentire la corteccia, conversare con qualunque animale senza assistere alla frustrazione di un tempo, girovagare senza doversi preoccupare di incrociare esseri viventi, fare il bagno sotto le cascate, nudi, compiacendosi l’uno dell’altro. Un giorno, proprio dopo uno di questi bagni, mentre si asciugavano sotto il sole cocente, Mesto si mise su Makàr per baciarlo, e senza esitare, d’istinto, afferrò il suo…tronco …saldamente. Mica era scemo. Certe cose sono proprio di famiglia. E da quel gesto, nacque tutt’altro, e si possedettero a vicenda, all’ombra di un salice piangente – ironia della sorte – in riva al lago. E finalmente Mesto capì. Capì cos’era la felicità che lo pervadeva, capì la sua capacità di sorridere, capì il trasporto e l’esigenza di stare sempre e solo con Makàr. Amore. Puro, semplice, quanto potente amore. Fecero l’amore senza tregua, senza inibizioni, senza accorgersi che quell’unione era talmente potente che attorno a loro la foresta rispondeva: le fronde degli alberi si tendevano verso di loro, la fauna era attirata da quella magia e cervi, scoiattoli, linci, oritteropi, ornitorinchi e ovviamente uccelli formarono un grande cerchio attorno a loro, non potendo fare a meno di attingere all’esplosione di sentimento che permeava l’aere. Infine, quando tra le labbra di Makar finalmente Mesto raggiunse l’apogeo del suo piacere, iniziò a ridere. Mai risata era stata più cristallina, più onesta, più schietta prima d’ora. E mentre questo piccolo miracolo era sotto gli occhi di tutti, altrettanto visibile fu una magia ancora più grande: attorno ai corpi sudati e abbracciati dei due, assieme alle risa stavano spuntando e sbocciando fiori di ogni tipo, colore e profumo, estendendosi sempre di più verso il confine del cerchio creato dalle creature che dimoravano in quei luoghi. E nel punto in cui le loro dita s’intrecciavano, mentre ancora Mesto rideva di dissolutezza e lascivia, quasi come una rivalsa contro il passato, nacque un meraviglioso ramo di Fiore di Giada.
Solo allora se ne accorsero, fermandosi a osservare il risultato di ciò che provavano.
Un prodigio, talmente potente da necessitare una reazione inversa a quella della maledizione, l’aveva vanificata, allora? Era davvero così? Il principe era finalmente libero?
Sentì che era così. Doveva esserlo.
I mesi successivi trascorsero nella pace più completa, intrecciandosi l’un l’altro fiori tra i capelli, rapiti e grati per l’amore che provavano reciprocamente e cantando Kumbaya.
Una sera in cui gli astri parevano particolarmente rifulgenti, fuori dalla foresta, diretti alla grotta di giada, davanti a un fuoco scoppiettante, avvolti insieme della pelliccia di lupo, ormai rassegnatasi, Mesto decise di rivelare infine a Makàr il motivo primario del suo viaggio, e di raccontargli la storia di sua sorella. Iniziò così, semplicemente, e dettaglio dopo dettaglio non si accorse che l’abbraccio del suo amato diventava sempre più rigido e il suo respiro sempre più irregolare. Poi percepì che stava piangendo, ed era triste.
“Makàr che ti succede?”
“Sei tu… sei tu che me lo stai facendo, Mesto. Devi sapere che abbiamo una ricorrenza millenaria che si chiama Agaetí Blodren. Durante la celebrazione, che dura svariati giorni, grazie alla magia che ci scorre nel sangue, noi elfi possiamo decidere, se ci aggrada, di usare la canzone magica del rito per migliorare non solo la foresta che ci circonda, ma anche noi stessi. Ed è quello che ho fatto anch’io, l’ultima volta. Sono io l’elfo di cui stai parlando, anche se non ho più lo stesso aspetto. Mi chiamavo Caleb, all’epoca. Sono io colui che ha rovinato la tua vita, il fautore involontario della tua maledizione! Tua sorella si è uccisa. lo l’ho vista quella stupida, mentre gettava via le scarpe stupende che aveva in mano e poi si buttava di sotto in stile Pocahontas. Ero appena stato all’arcobaleno, per trafugare l’oro dal calderone dei Lepricauni, e mi sono fermato a osservarla quando mi sono accorto della sua presenza! Un po’ di moine, del sesso fantastico e qualche settimana insieme e subito a gridare ‘Amore, Amore’! Non la sopportavo più!”.
Mesto non credeva alle sue orecchie. L’uomo che amava, al punto da rinunciare ai suoi obiettivi e rimandare tutto il resto, colui che gli aveva donato la felicità, che aveva spezzato – o almeno così credeva – la sua maledizione, in realtà lo aveva fatto soltanto per sedurlo. E come se non bastasse, era lo stesso elfo che aveva picchiato Gaia tanto brutalmente da spingerla a suicidarsi. Peggio di Beautiful. Nel frattempo, l’erba attorno a lui non c’era più, solo fredda e nuda terra, e i fiori tra i capelli erano un lontano ricordo ormai.
“Ma allora dimmi – chiese disperato Mesto – se mia sorella si è uccisa, considerando che il suo dono era inverso alla mia maledizione, vuol dire che lei a causa tua lo aveva perso! Per questo l’ha fatto!”.
“Stupidi tutti e due, nonostante siate così diversi” rispose freddamente Caleb “certe cose non svaniscono! Non sono agenti esterni a influire su di esse, ma soltanto noi dal nostro inconscio. La certezza di Gaia di non poter mai più essere felice, la sua incapacità di apportare beneficio con i suoi sorrisi e il suo gesto estremo, sono dovuti alla convinzione assurda che il suo dono fosse sparito a causa di un unico evento, e allo stesso modo…”.
“Allo stesso modo – lo interruppe Mesto, sforzandosi di essere chiaro mentre piangeva a dirotto – ho pensato di poter essere felice e sorridere e che la mia maledizione fosse svanita, solo perché ero convinto di amarti!”
“Sbagliato. Tu mi ami. Eri convinto che io amassi te, ed è questa evidentemente la cosa che brami di più nell’intero cosmo. Ma io sono immortale, l’amore no. Ora me ne vado. Gli occhi mi bruciano come se stessi affettando cipolle per un esercito. Addio, lagna umana”.
Corse via così velocemente da sembrare invisibile, sicuramente diretto verso il folto della sua foresta. Immobile contro un albero ormai completamente rinsecchito, Mesto pensò di tutto.
Pensò di seguirlo, ma senza la sua guida non avrebbe mai saputo orientarsi in quella labirintica selva.
Pensò di volerlo uccidere con le sue mani.
Pensò che meritasse una disperazione eterna come la sua.
Addirittura pensò che forse potesse convincerlo che il loro fosse vero amore.
E quest’ultimo pensiero lo fece cadere in uno sconforto ancora più grande, e si vergognò moltissimo. Per tre giorni rimase immobile nello stesso punto, perso nei pensieri e terrorizzato dal dover vedere di nuovo la maledizione agire, piangendo tutto il dolore di cui fosse capace, senza badare ai pallidi tentativi della testa di lupo sulla spalla di rassicurarlo. Poi, con gli occhi rossi e gonfi come palle da croquet, si alzò e cominciò a camminare, ignorando il più possibile la vita che moriva attorno a sé. Percorse la strada più breve che potette per ritornare alla neve dell’inverno che aveva percorso in slitta, recuperò quest’ultima alla quale erano rimasti attaccati solo gli orsi, che ancora sgranocchiavano resti di caribù, e iniziò il viaggio di ritorno a casa. Aveva conosciuto l’amore senza riconoscerlo, illudendosi che potesse rendere felice uno come lui, quando invece l’amore non può nulla se non svanire.
In stato catatonico tornò al regno, e tutto restò come se nulla fosse mai accaduto.
Alcuni dicono che ogni giorno Mesto, ancora oggi, si faccia portare in stanza un ramo di Fiore di Giada, e lo faccia poggiare abbastanza lontano da poterlo guardare mentre appassisce lentamente per poi diventare un mucchio di polvere che il vento soffia via fuori dalla finestra.
Di Francesco Funaro
Foto Cover: Alice Alnari – Pexels.com
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.