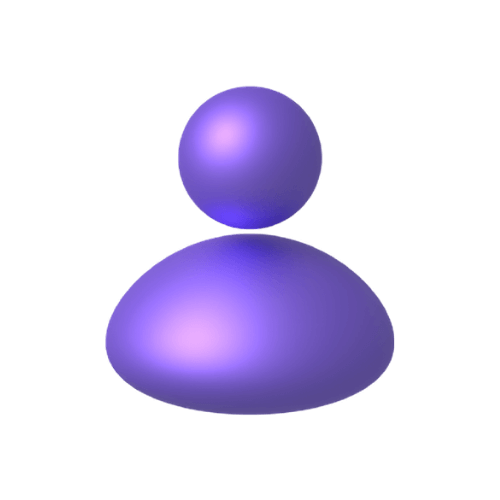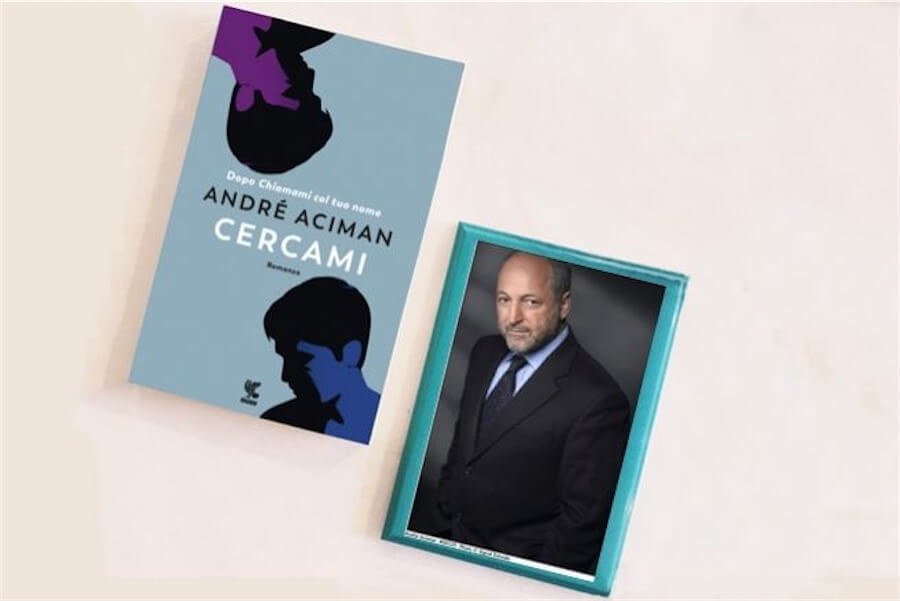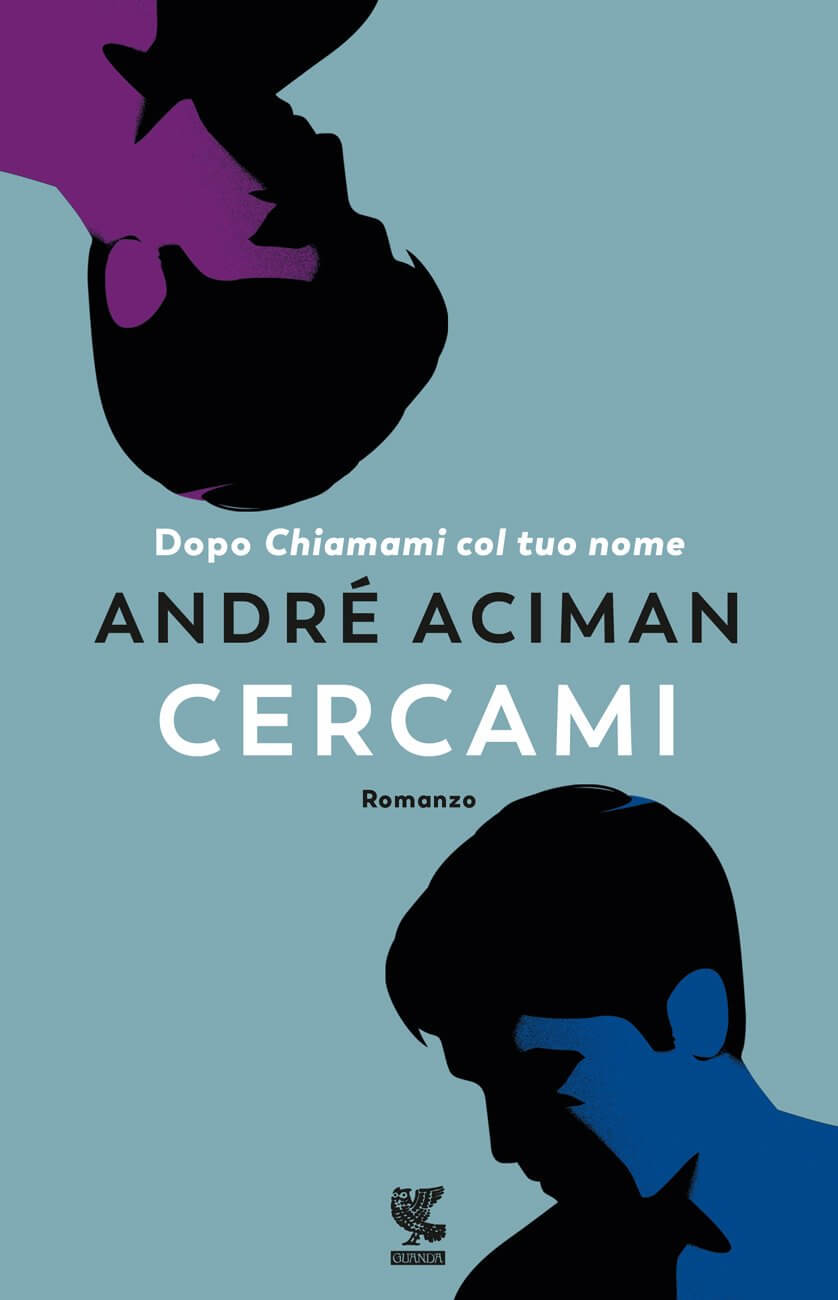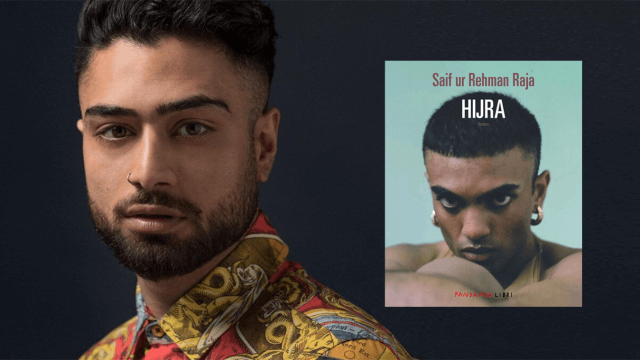“«Me la ricordo.» «Te la ricordi» gli ho fatto eco. Mi ha guardato e ha sorriso. Mi ha fatto piacere. Forse perché sapevo che mi stava prendendo in giro. Vent’anni sono ieri, e ieri è stamattina presto, e stamattina sembra lontana anni luce. «Sono come te» ha detto. «Mi ricordo tutto.» Mi sono fermato un secondo. Se ti ricordi tutto, volevo dirgli, e se sei davvero come me, allora domani prima di partire o quando sei pronto per chiudere la portiera del taxi e hai già salutato gli altri e non c’è più nulla da dire in questa vita, allora, una volta soltanto, girati verso di me, anche per scherzo, o perché ci hai ripensato, e, come avevi già fatto allora, guardami negli occhi, trattieni il mio sguardo, e chiamami col tuo nome.”
Dove eravamo rimasti? Qui, all’explicit più emozionante di sempre, e, per quel che concerne la settima arte, alle lacrime dinnanzi a un camino – la villa di Moscazzano è diventata luogo di culto, chi scrive ha programmato in sua funzione le vacanze – ardente come il suo cuore disperato, di Timothée Chalamet, giovanissimo e meraviglioso Elio (protagonista dell’opera migliore dell’ottimo Guadagnino, che ha dato finalmente un Oscar, per la sceneggiatura, a un gigante come James Ivory) che per la prima volta ha amato, è stato riamato e sperimenta lo strappo tremendo della separazione, per giunta da un Oliver (Armie Hammer) bello come quei sogni che al risveglio ti rimangono impigliati alle ciglia e non ti fanno rendere subito conto della loro irrealtà. Che l’amore è tutto è tutto ciò che ne sappiamo, si sa, che il desiderio sia una febbre irresistibile pure, che il primo momento nella vita in cui non ci sentiamo incompleti, sbagliati, vuoti, inutili, di peso, trasparenti, fragili, insicuri e soli sia un attimo che ci definisce per sempre anche: ma il tempo, divinità che tutto fagocita, passa, inesorabile. E anche in questo caso trascorrono anni, che si perdono come lacrime nella pioggia.
Da qui, dunque, si riparte, col coraggio che serve a prendere in mano la propria vita, e andare avanti: è il coraggio il fulcro di Cercami (Guanda: traduzione, magnifica, come già lo fu quella di CMBYN, di Valeria Bastia; in libreria dal 28 ottobre, ed è prossimo un tour italiano dell’autore), romanzo intenso, avvincente, appassionante, riuscito, compiuto, nonostante non sia affatto facile riuscire a mantenere solidità, forza, potenza e coerenza dopo un successo così trasversale e dirompente. E Cercami che non è semplicemente, ammesso e non concesso che tale avverbio possa avere un senso in questo contesto, il seguito, sempre a firma di André Aciman, che indaga l’anima, il sentimento, la passione, l’amore, il sesso, il desiderio, la tenerezza, la dolcezza, la disperazione, la speranza, la fragilità come nessun altro, senza retorica, con una delicatezza che commuove, appassiona, strazia, di Chiamami col tuo nome: è un romanzo, diviso à la Tondelli in movimenti, tempo, cadenza, capriccio, da capo, che si legge col cuore in gola, come febbricitanti, è travolgente, commovente, trascinante, emozionante, da cui è impossibile staccarsi e per la cui fine ci si duole, perché se ne sarebbe voluto ancora, e ancora, e ancora, che in realtà ha piena autorevolezza, compiutezza, consapevolezza, coscienza di sé pure in totale autonomia.
Se anche non si sapesse nulla di Samuel, di Elio, di Oliver, se anche non si conoscesse Roma e la sua seduttività marcescente, se anche si provenisse da un altro pianeta, se anche non si credesse nemmeno all’esistenza dell’amore, se anche si fosse involucri vuoti, senza stimoli, tutto, forse, sarebbe possibile, tranne che restare indifferenti. Perché è una prova di coraggio e la prova che il coraggio esiste, e che è un dovere, che abbiamo prima di tutto verso noi stessi, perché non potremo mai essere felici senza di esso.
“Devo tornare, Micol. Perché? Perché la mia vita si è fermata lì. Perché non me ne sono mai andato del tutto. Perché il resto di me qui sembra la coda mozzata di una lucertola, che si dimena e si divincola mentre il corpo è rimasto dall’altra parte dell’Atlantico in quella meravigliosa casa sul mare. Sono stato lontano fin troppo a lungo.”
Tutto inizia su un convoglio che si muove lungo dei binari. Si danno subito del tu: lui, professore universitario americano, in Italia da trent’anni ma ancora con un forte accento, è già seduto a leggere sul treno diretto a Roma dove terrà una conferenza sullo straziante sacco di Costantinopoli a opera degli Ottomani e vedrà, non senza timore di apparire un’imposizione o una noia, di nuovo, come ogni cinque-sei settimane, suo figlio, che vive lì, ma è in procinto di trasferirsi, e forse, chissà, di incontrare una sorpresa del destino, a Parigi, e che verrà a prenderlo al binario per il solito giro in città; il ragazzo è un pianista, di successo sul lavoro, meno nelle questioni di cuore, anche perché ancora vive nel ricordo di un amore che ha potuto essere meno di quanto vagheggiato, quello per un fugace ospite estivo nella casa di famiglia in Riviera, ora lontano, che non gli scrive e a cui non scrive perché entrambi sanno che la fiamma non s’è spenta, un uomo con un’esistenza apparentemente serena, a New York, con due figli adolescenti, una moglie con cui già stava da fidanzato prima di incontrare, conoscere, amare lui, che gli ritorna alla mente a vent’anni, quando suonano per lui al pianoforte quello stesso celebre Arioso. Un amore che era esploso così:
“Eppure, un paio di settimane dopo il suo arrivo, ogni notte volevo che uscisse dalla sua camera, passando non dalla porta, ma dal balcone. Volevo sentire la sua portafinestra aprirsi, le sue espadrillas sul balcone e poi il rumore della mia portafinestra, mai chiusa col fermo, che veniva sospinta, e poi lui che entrava in camera mia dopo che erano andati tutti a dormire, si infilava sotto le lenzuola, mi spogliava senza chiedermelo e, dopo avermi fatto venire voglia di lui più di quanto pensassi di poter mai desiderare un altro essere vivente, con delicatezza, dolcemente, con la gentilezza che si usa tra ebrei, si insinuava nel mio corpo, con delicatezza, dolcemente, dopo avere ascoltato le parole che ormai provavo da giorni: Ti prego, non farmi male, che in realtà volevano dire: Fammi tutto il male che vuoi.”

“Non sono forse questi i due scenari peggiori? Da un lato ciò che sarebbe potuto accadere ma non è mai accaduto, dall’altro ciò che potrebbe ancora accadere anche se non nutriamo più speranze.”
Lui è Samuel, il padre di Elio, l’uomo che ha pronunciato in Chiamami col tuo nome il discorso che ogni figlio che cerca amore e comprensione spera di sentirsi fare. Questo:
“«Come vivi la tua vita sono affari tuoi. Ma ricordati, cuore e corpo ci vengono dati una volta sola. La maggior parte di noi non riesce a fare a meno di vivere come se avesse a disposizione due vite, la versione temporanea e quella definitiva, più tutte quelle che stanno in mezzo. Invece di vita ce n’è una sola, e prima che tu te ne accorga ti ritrovi col cuore esausto e arriva un momento in cui nessuno lo guarda più, il tuo corpo, e tantomeno vuole avvicinarglisi. Adesso soffri. Non invidio il dolore in sé. Ma te lo invidio, questo dolore.» Prese fiato. «Magari non torneremo mai più sull’argomento. Ma spero che non me ne vorrai per averlo tirato fuori. Sarò stato un padre terribile se, un giorno, tu dovessi pensare che volevi parlare con me e ti è sembrato di trovare la porta chiusa o non abbastanza aperta.»”
E Samuel non smette di preoccuparsi per Elio.
“Tanto tempo fa c’era una persona, e quando gli ho chiesto se aveva qualcuno anche adesso, mi ha risposto scuotendo la testa: ‘Non chiedere, papà, non chiedere’. Il che può voler dire tutto e niente, ma non so che cosa sia peggio. Un tempo si confidava con me.”
Il tempo, di nuovo il tempo, maledetto tempo, che non s’arresta mai, che fa cambiare vita: Samuel, dopo che, come avrebbe detto Edith Wharton, qualcuno ha finalmente fatto cadere il piatto coi cetriolini, ha gettato la maschera, ha detto la verità, ha rinunciato all’ipocrisia di comodo, preso il toro per le corna e scelto la strada dell’onestà, ritrova tenerezza e umana comprensione, dopo che troppo a lungo a rinunciato a essere quel che voleva – ma non è mai troppo tardi, insegna Eliot – negli occhi di una sconosciuta, perché siamo tutti uguali, nudi, soli e tremanti di fronte all’illusione di esserci imbattuti in qualcuno per cui siamo perfetti così come siamo.
“Niente vergogna, niente segreti. Stasera si gioca a carte scoperte. Niente doccia, niente spazzolino da denti, niente collutorio, niente deodorante, niente di niente. Ti ho rivelato il mio segreto più profondo, e tu mi hai rivelato il tuo. Quando avremo finito, non ci deve essere nulla tra noi, o tra noi e il mondo, perché voglio che il mondo ci conosca per come siamo insieme. Altrimenti tutto questo non ha alcun senso…”
Elio, invece, nel tempo ci è invischiato:
“«Non te l’ho mai detto, papà, ma una sera ero sbronzo perso, avevo appena vomitato vicino alla statua di Pasquino; più stordito di così non potevo essere, eppure qui, appoggiato a questo muro, ubriaco com’ero, con Oliver che mi sorreggeva, capii che era questa la mia vita, che tutto ciò che avevo sperimentato prima con altri non era nemmeno un abbozzo maldestro né una prima stesura di ciò che mi stava capitando in quel momento. E adesso, a distanza di dieci anni, quando guardo questo muro sotto questo vecchio lampione, sono di nuovo con lui e non è cambiato niente, lo giuro. E mi sentirò così anche fra trenta, quaranta, cinquant’anni. In vita mia ho incontrato tante donne e ancora più uomini, ma ciò che è scritto su questo muro offusca il ricordo di chiunque abbia conosciuto. Quando vengo qui, che sia da solo o con altra gente, con voi per esempio, sono sempre con lui. Se restassi qui un’ora a fissare questo muro, starei con lui per un’ora. Se parlassi con questo muro, mi risponderebbe.» «E che cosa ti direbbe?» domandò Miranda, completamente rapita dal pensiero di Elio e del muro. « Che cosa mi direbbe? Semplice: ‘Cercami, trovami’.» «E tu che cosa risponderesti?» «La stessa cosa. ‘Cercami, trovami.’ E siamo entrambi felici. Adesso lo sapete.»”
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.