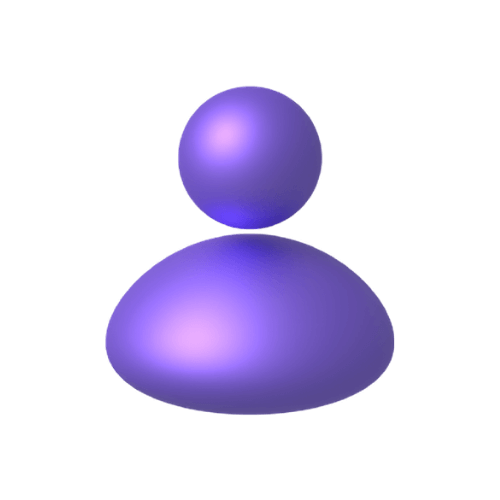Il solito giovedì, libera uscita. Sera nebbiosa e fredda, l’inverno dentro le ossa.Forse più pungente nel mio corpo che fuori, fra i palazzi addormentati in una soffice oscurità. Appena visibile l’insegna luminosa sopra una farmacia, una croce verde chiaro che si accende a intermittenza. Io, col solito senso di colpa, pesante come un macigno, dopo avere inventato la solita scusa per mia moglie, ingobbito da tutte le bugie ormai settimanali, che sole mi permettono di sopravvivere, girovago per i luoghi maledetti dove giovani uomini si vendono per poco. Omosessuale da sempre, mai dichiarato, mai riconosciuto,infedele. Notti accanto a un corpo di donna, carne esigente carica di tutta la forza della terra, carne invadente e misteriosa, fatta di anfratti, territorio mai capito ed esplorato solo saltuariamente, e con paura. Un oltraggio, per lei e per me. Perpetrato da anni sognando corpi di uomini uguali al mio, sognando toraci pelosi, membri maschili e concedendomi soltanto fugaci contatti sulle sedie rosse e sdrucite di un cinema porno di periferia.
Poi con gli anni, finalmente, una sera per me, mai più messa in discussione. E allora i contatti sono diventati rapporti completi consumati nelle dark room dei locali, o in macchina, cercando sui colli luoghi appartati, oscurità accoglienti e anfratti di strade sterrate dove sentirmi al sicuro. Passivo. Finalmente fedele alla mia carne, al mio desiderio di essere anche femmina, o di possedere un corpo che non mi spaventa. Perché mi ci posso specchiare. Perché è come me.
Cancellare tutta la settimana. Cercare di non fare esistere i giorni. Lunghe passeggiate per tacitare l’inquietudine e il cuore, a volte, che batte come impazzito.
Vivere davvero un solo giorno.
Era di nuovo giovedì dopo una settimana trascinata con stanchezza fra il lavoro in azienda e gli impegni famigliari. La mia insospettabile doppia vita. Dopo un giro per il parcheggio mi fermai al solito gay pub. Pensavo di bere qualcosa osservando le persone e poi di entrare nella dark room per offrirmi a qualche membro senza volto capace di soddisfarmi senza aggiungere la vergogna di guardarmi negli occhi. Ma entrò lui. Vederlo fu come un turbine, l’esuberanza del suo corpo mi prese alla gola. Cercai di fare finta di niente, continuai a bere un negroni secco che ad ogni sorso mi nauseava. Conati di vomito, lunghe boccate di fumo e poi gli occhi fissi sul suo corpo, senza decenza. Era giovanissimo, capelli neri, occhi scuri, quel profumo mediterraneo capace di inebriarmi, di farmi perdere la testa da sempre, lo emanava ad ogni passo, i suoi pori erano un pericoloso ventilatore afrodisiaco e il suo sguardo aggiungeva al tutto una studiata malizia. Conscio del suo fascino, del suo bel culo magro stretto dai jeans, si avvicinò al bancone del pub gay e scambiò due parole con il barista ridendo senza sguaiatezza ma con una certa grazia studiata, ma non eccessiva.
Io bevvi ancora una lunga sorsata per darmi un tono, sentivo l’indecenza del mio desiderio, violento, quasi brutale e volevo ricacciarlo nelle viscere nascoste, dove l’avevo sempre lasciato, anzi seppellito. Mai un sentimento, mai nulla capace di mettere a repentaglio il mio faticoso equilibrio, solo amplessi. Solo persone da non rivedere mai più, o magari da pagare.
E invece mi guardò anche lui.
Io quarantenne con un inizio di stempiatura, con quell’aria perennemente a disagio che mi faceva apparire scostante.
Si avvicinò.
Mi chiese di offrirgli da bere.
Non dissi niente.
Ordinai un altro negroni e la testa cominciò a girarmi, tutto attorno cominciò a girare. Facce sul soffitto, odori, corpi muscolosi, luci stroboscopiche, tutto si mischiava in una sola sensazione fulminante come una scossa improvvisa, e psichedelica come una droga ingurgitata in fretta.
Lui beveva e guardava altrove, salutava tutti, qualcuno si avvicinava e lo baciava o gli sussurrava qualcosa in un orecchio.
Era una vera puttana e si divertiva a ostentarlo, a mostrarmelo.
Poi si girò e mi chiese come mi chiamavo.
Io dissi Rodolfo, il primo nome che mi venne in mente. Ancora codardo. Come sempre.
Lui fece una risata e poi mi portò dentro la dark room.
Ricordo solo le sue mani su di me, il suo membro nella mia bocca, quel sapore che apparteneva alla mia memoria, a qualcosa sperimentato da bambino e poi solo immaginato. Il sapore della sua carne era un sogno, una sensazione onirica e nello stesso tempo molto fisica e pensai che in quel momento il tempo, poteva, forse, fermarsi.
Esplorò il mio corpo con la lingua, annusò il mio torace, mi leccò le ascelle e l’ombelico e poi mi girò e volle possedermi, giungendo in fretta ad un orgasmo silenzioso.
Mi salutò rapidamente, uscendo, e se ne andò portando con sé il suo corpo di oltraggiosa bellezza come un orpello prezioso. Disse che andava da un amico a fumare spinelli e a sniffare coca. Nulla appariva immorale detto da quella bocca che avevo appena assaporato, succhiato a labbra protese, lasciato scivolare sul mio pene.
C’era purezza in lui, in un certo senso. Io la vedevo.
Mi diede un appuntamento al sabato seguente.
Disse che si chiamava Giuliano, e rise di nuovo.
Una nuova scusa per mia moglie. Una scusa qualsiasi. Cominciai a pensarci appena uscito dal locale, immergendomi in quella notte che mi appariva meno fredda, adesso che ero come febbricitante.
Malato. Di desiderio e di paura.
Con quella spossatezza che segue il sesso consumato con la frenesia di certi luoghi cupi e odorosi di umori e
sudore. Nell’oscurità piena di ombre curiose.
Eppure mi sentivo limpido, come un cristallo trasparente, e le luci della città, ridiventate visibili, si riflettevano sulla mia pelle.
Pensai al prossimo appuntamento.
L’avrei portato in un albergo. Ecco, in una pensione che avevo già individuato vicino alla stazione.
Immaginai le occhiate del portiere, mi tremarono le gambe. Per fortuna ero ormai arrivato a casa e mi infilai nel letto. Mia moglie dormiva già, voltata sul fianco. Mi rannicchiai dalla mia parte senza nemmeno sfiorarla. Seguirono giorni sfilacciati, di cui non ricordo quasi nulla.
Una malattia, uno stato di debolezza e di abbandono.
"Forse mi sta venendo l’influenza"
Dissi a mia moglie per giustificare la mia apatia e il disinteresse per i suoi discorsi. Avevo un pensiero fisso. Drink e albergo, poi magari dei soldi, sì gli avrei dato dei soldi, e magari li avrebbe rifiutati. No, avrebbe potuto offendersi, drink e idea dell’albergo buttata lì con noncuranza, era la cosa migliore. Se fosse venuto. Perché poteva non venire. Certo poteva, ma forse stavo proiettando le mie paure, non ci dovevo pensare, certo che no. Perché dare un appuntamento e non venire? Era assurdo. Ma era la prima volta che provavo un simile trasporto. Che andava oltre quegli incontri fugaci e un po’ deprimenti dei miei giovedì. E che faceva affiorare emozioni violentissime che avevo cercato vanamente di seppellire per tanti anni. Verrà. Me l’ ha detto. E’ stato come un appuntamento. Anzi un vero e proprio appuntamento preciso. Ci vediamo sabato. Non ricordo la voce. Ma il suo corpo sì. Ce l’ ho fisso nella testa, costantemente.
Come scusa inventai una cena di colleghi chirurghi con un informatore farmaceutico."Non è prevista la partecipazione delle mogli, se no sarebbe stato bello portarti con me"
"Non importa, inviterò a cena un paio di amiche"
La sua bocca sul mio torace, le sue labbra che indugiano sui miei capezzoli.
La sua mano sul mio pene e poi lui che mi spinge la testa e mi fa inginocchiare.
Lo stesso sogno, ogni notte.
E un risveglio afasico. Sudato, confuso.
Arrivo al locale prestissimo, non c’è quasi nessuno.
Bevo.
Il suo corpo offerto a me, più vecchio e più brutto in sacrificio.
O forse mi desidera. Per lui potrei lasciare tutto, cambiare tutto. Forse mi vuole, non era tenuto a darmi un appuntamento.
Il desiderio è strano, senza direzioni prestabilite.
Bevo ancora.
Non arriverà lo so, e io ne morirò, perché ormai il contagio è reale e attivo.
Un virus forse letale.
Ho dimenticato il cellulare acceso, mia moglie prova a chiamare, leggo il suo numero sul visore e non rispondo, non me ne frega niente.
Prova ancora, e ancora.
Nonostante la musica il suo squillo in sottofondo mi disturba.
E’ caparbia mia moglie, quando vuole.
Appena il telefono tace per un attimo, lo spengo.
La sua carne abbondante e seminuda nel letto.
Le mie carezze timide sul suo seno, il mio pene poco reattivo.
Forse la donna sbagliata, la persona sbagliata.
E poi il bambino.
Sei anni fra un mese. Lo vedo. Alle medie o al liceo, che, interrogato, risponde alla professoressa: mio padre è gay.
Accarezzo la prospettiva, la depuro della sua anormalità, della sua mostruosità.
Mio padre è gay, gay gay GAY.
Vive con un uomo, mia madre è distrutta, no mia madre si è rifatta una vita, mia madre niente, lei è perfetta , giusta, è lui che è anormale, assente, morboso.
Non posso. Mi avvicino al guardaroba per andarmene ma poi torno indietro.
Mio padre è infelice, frustrato , codardo, infido.
Mio padre ha una doppia vita, compie giri clandestini ogni settimana nelle zone oscure della città dove i corpi si dissolvono e gli uomini diventano ombre. Mio padre ha paura del corpo di mia madre, non la desidera, forse in passato l’ ha creduto possibile, ma ora non più.
Mio padre ha sempre avuto paura, paura, tanta paura, TERRORE.
Non è peggio, forse?
Questa sera è meno freddo, e la nebbia si è diradata, mi pare.
FINE
di Francesca Mazzucato
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.