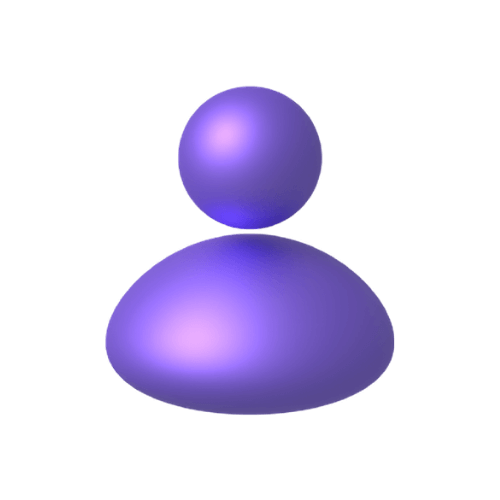Si dice che la distanza sia l’oblio,
ma io non sono di quest’avviso.
BOLERO POPOLARE
Sapevo che attraversando l’oceano avrei perso il nome. L’oceano, quello Atlantico, è vastissimo. Caraibi e Mediterraneo inclusi. Una distanza eccessiva e un eccesso di sostanza vana, l’acqua, incline alla dissoluzione e all’oblio come nessun altro liquido, a eccezione dell’acquavite di canna. Tant’è che uno dei miei giochi preferiti era inventarmi nomi possibili per quando sarei stato nell’altro mondo; e per nomi intendo esistenze.
Non potevo immaginare fino a che punto avrei dovuto, qualche anno dopo, forzare il mio ingegno. Il mondo picaresco dell’Avana fu una università a distanza (alle volte vicina) che mi addestrò all’arte sommaria della simulazione e dell’innesto di alcuni esseri con altri, conservando dei primi appena un’espressione, qualche dettaglio sufficiente comunque a collegare un personaggio all’altro fino a formare una sorta di intima famiglia.
Il gioco cominciò sul serio quando finii in carcere per scontare una condanna di un anno.
Ero già dal barbiere del Castello del Morro quando capii che se lì dentro avessi continuato a cercare di somigliare a ciò che restava di me sarei morto ben presto. Così adottai l’identità di un essere abbandonato, un po’ sciocco e con sguardo da vittima, che faceva al caso. Nessuno avrebbe rifiutato di aiutare una simile incarnazione dell’abbandono universale.
Il Castello del Morro era il penitenziario principale dell’Avana, dal momento che l’altra fortezza d’epoca coloniale doveva essere destinata a usi culturali. Vi erano condotti tutti i prigionieri che da quell’imponente mole di pietra venivano smistati in altre prigioni o campi di lavoro. Era un inferno. L’eco delle volte diventava un clamore sordo e confuso di voci: ronzio dei rasoi per tagliare i capelli a zero e zoccoli di legno, le scarpe abituali, probabilmente le uniche in grado di resistere all’umidità imperante, una specie di freddo liquido capace di corrodere le ossa di un titano. Il barbiere, la cui missione era rapare crani con ampie tosate, come chi traccia larghi paralleli e meridiani su un mappamondo, ti sottoponeva al primo interrogatorio non ufficiale:
– Perché sei qui?
– Mi ci hanno portato… – risposi cercando di tagliar corto.
– Sei molto spiritoso, ciccio. Magari nella corsia numero 6 hanno bisogno di un comico.
E continuò a farmi scorrere l’arrugginito tosaerba da un orecchio all’altro. In quel momento non fui in grado di interpretare la sua frase, che mi sembrò piuttosto una battuta di spirito. In realtà era una sinistra minaccia. Nessuno è più pettegolo di un carcerato. La trasmissione orale di qualsiasi notizia, voce o calunnia è l’unica cosa che permette a un detenuto di vivere. La prima cosa da sapere è perché gli altri sono lì dentro. Certi reati avevano nomi in codice. Scala e scasso stava per ‘furto con scasso in appartamento per mezzo di una scala’ e quando si diceva un facile, in realtà ci si riferiva a un ‘taccheggio simulando sbadataggine’. I reati più abominevoli erano considerati, nell’ordine, la corruzione di minori e lo stupro. Per il primo non c’era alcun perdono. I divorapupi erano l’infamia personificata e si doveva continuare a punirli anche dietro le sbarre. Io ero stato condannato come corruttore con un eufemismo legale chiamato ‘abusi immorali’, un abuso, nel gergo del carcere. Per fortuna, a parte l’insistente barbiere, nessuno mi chiese niente in quei primi giorni di scombussolamento. Uno che sapeva che dovevo iniziare a scontare la condanna mi consigliò: “Finchè stai nel Morro, non parlare con nessuno”, così me ne stetti zitto fino a che nella corsia 7 uno dei temuti capi mi disse:
– Parla, gatta morta.
Era un enorme esemplare di bue con tatuaggi verdi. La lingua mi si trasformò in una scultura di marmo rosa e cominciai a sudare. La corsia 7 era al pianterreno e non era delle peggiori. Un lungo tunnel di pietra simile all’idea che uno si fa delle catacombe romane nell’estetica di Cecil B. de Mille, martiri compresi. Era una corsia mista: prigionieri già condannati e altri detenuti in attesa di giudizio. C’erano giovani e vecchi, matricole ed ergastolani consumati. Lì vigeva la legge del carcere, come in tutti i film e in tutto il mondo. Non era la legge del più forte, ma quella del più sanguinario. A capo della 7 c’erano due mostri: ciascuno aveva il suo stile – un assassino, detto affettuosamente il Macellaio di Cascorro, e una checca, Sabor, Sapore. Qualche tempo dopo seppi che il Macellaio faceva davvero il macellaio in un paesino della provincia di Camagüey, Cascorro. Era dentro per aver sgozzato la moglie, e non con un coltellaccio del mestiere bensì usando un pettine a mò di sega. Sabor invece era un ladro di gran classe e di tanto in tanto faceva una capatina in carcere, dove ritrovava sempre vecchi amori.
Ci arrivai verso le sei del pomeriggio, dopo un lungo giorno di digiuno, il barbiere, il cambio degli abiti civili con l’uniforme grigia, le fotografie di fronte e di profilo, le impronte digitali, la visita medica, la fumigazione e la lunga passeggiata attraverso le gallerie con grate che avrebbero potuto essere pezzi da museo: niente sembrava avere meno di cento anni, salvo alcune persone e le serrature sovietiche in metallo cromato. Una volta dentro il tunnel paleocristiano una voce tuonò:
– I vecchi in quest’angolo, i negri a parte, i testimoni in fondo!
Si riferiva ai Testimoni di Geova, una specie di gruppo folclorico che abbondava nelle carceri cubane di quegli anni. Rimasi in mezzo alle file di brande a castello, esattamente dove non dovevo, guardando verso l’unico punto da cui proveniva la luce: la grata coloniale, corrosa dal salnitro di un mare che si udiva sciabordare contro i muraglioni della scogliera. Il Macellaio mi si avvicinò e vide che tremavo. Ho sempre pensato che in quel momento il gigante non intendesse colpirmi: non aveva senso ammazzare un morto ed io ero letteralmente freddo, rigido e senza respiro.
– Sei sorda?
Fu Sabor, con un asciugamano giallo portato come un turbante brasiliano, a salvarmi da qualcosa di sgradevole, quasi sicuramente uno sputacchio del capo o una legnata del suo aiutante nano, una specie di cane idrocefalo che lo seguiva dappertutto.
– Fila con i testimoni, di corsa! – mi ordinò spalancando gli occhi come Bette Davis.
I testimoni erano ammassati insieme ad altri materiali di scarto contro la parete posteriore del tunnel, nella zona più umida. Dalle latrine vicine filtrava un filo di orina che ci serpeggiava tra i piedi. Uno di loro mi fece un segno che non mi sembrò ostile e mi sedetti accanto a lui su due mattoni sporgenti. Quelle voci e quegli ordini si riferivano alle pulizie che dovevano precedere il pasto. Da lì, mentre inalavano porzioni equivalenti di aria e di merda, le voci dalla grata si distinguevano a malapena; al contrario, attraverso la pietra arrivavano altri brusii e, a volte, una specie di scala musicale, che presto associai al più terribile dei richiami delle guardie, quando, procedendo senza fermarsi, facevano vibrare contro le sbarre i lunghi manganelli di legno duro e verniciato.
Il Macellaio e Sabor erano amanti. Lo venni a sapere tre giorni dopo. Occupavano i primi due giacigli. Il nano dormiva sotto la branda a castello del Macellaio, su un materassino sistemato sulle lastre di pietra. C’erano 70 letti e 150 prigionieri in quel posto. Ogni notte ci ficcavano sotto le brande, a due a due. A mezzanotte, il pavimento, per gli effetti della marea, iniziava a trasudare gocce di sale dalla puzza di zolfo. Quando pioveva, le gocce si moltiplicavano e si allagava tutto fino alle caviglie. Uno di quei giorni, all’alba, abbandonando nudo e inturbantato il suo regno al fondo della stanza, Sabor mi riscattò:
– Su, vieni con me.
Un nuovo terrore cominciò a corrermi per la schiena. Sabor fugò ogni mio dubbio.
– Non essere sciocca, vieni – e sorrise mostrandomi gli spazi un tempo occupati dai denti. Raccolsi il mio fagotto (un libro, due saponi, due matite, un mezzo asciugamano) e mi sedetti sul bordo della sua branda.
– Tu non sei testimone – non me lo stava chiedendo. Lo sapeva. Io cercai di stringermi nelle spalle dentro al mio personaggio di povera orfanella.
– Guarda che a me non me ne frega niente. È meglio che ti prendano per testimone, ‘ste bestie. Vuoi un cioccolatino? mi diede una tavoletta di cioccolata molliccia e mi si avvicinò ancora di più.
– Vedi di non farti mandare nella 6. È quella delle checche. E quelle streghe ti caverebbero gli occhi per puro piacere. Finché ci sono qui io, non preoccuparti. Se qualcuno t’importuna, fammelo sapere. Si vede che sei una persona di cultura e io ho profondo rispetto per l’arte.
Quel pezzetto di cioccolata rancida e l’ala protettiva di Sabor mi restituirono la volontà perduta. Tornai in fondo al tunnel e provai qualcosa di simile alla voglia di vivere, o per lo meno di non morire proprio quella notte.
Ben presto però imparai che in carcere sensazioni del genere non arrivano al giorno dopo. All’alba, tra le sirene e l’appello dall’altoparlante, che pareva più una litania di defunti che un richiamo a mettersi in fila, mi ritrovai a prendere congedo da Sabor, quasi felice di non dover più rivedere il cane-nano del Macellaio, pur senza sapere esattamente dove ci stavano portando col vecchio cellulare blindato, strapieno dei più tenebrosi compagni di viaggio che avessi mai avuto. Qualcosa mi diceva che il personaggio che mi aveva permesso di sopravvivere in quei giorni nel Castello del Morro non mi sarebbe servito a niente nella nuova destinazione. E infatti fu così. Non feci nemmeno in tempo ad abituare lo sguardo al buio del furgone che una voce mi lambì l’orecchio con fermezza:
– Girati che t’inculo, voglio distrarmi fino a quando arriviamo a Quivicán.
– Come fai a sapere dove siamo diretti?
– Tu che ne pensi? – e un fiotto di saliva mi lubrificò caritatevole… tra le natiche.
Nell’altro carcere fui infermiere, disegnatore, insegnante di matematica, addetto ai turni della sorveglianza e aiutocuoco. Quando stavo per esaurire il repertorio ammesso dal mio personaggio di infelice servo, un pomeriggio di quelli in cui il sole spaccava senza misericordia i tetti di zinco, un altro detenuto mi disse:
– Te ne vai.
– Mi mancano sei giorni – feci tanto per dire, in realtà me ne mancavano sette per finire di scontare la condanna.
– Lo so. Te ne vai.
Non riuscii a dormire. E infine tornai alla strada dell’Avana e non alla libertà che sono cose molto diverse, se non addirittura opposte, come posso dire adesso, da qui, così lontano ma così vicino a tutto questo.
Roger Salas
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.