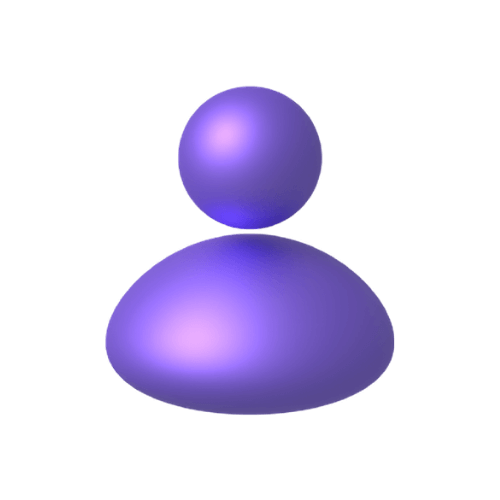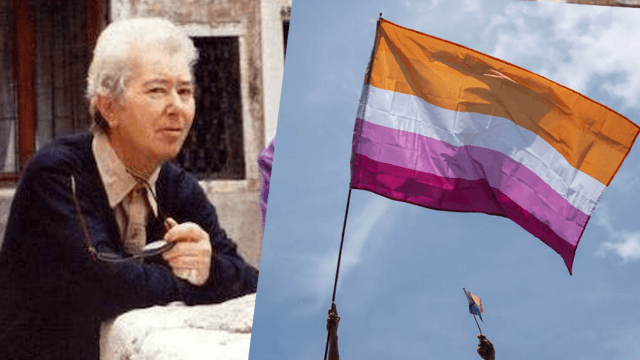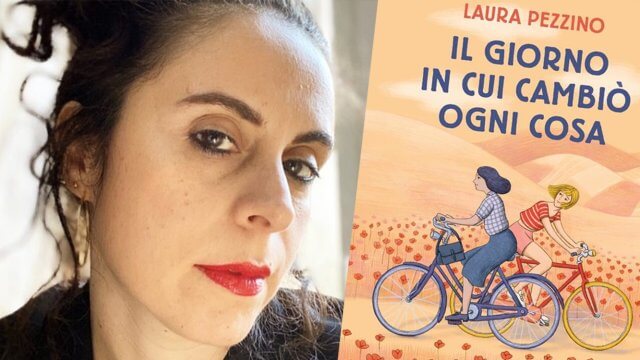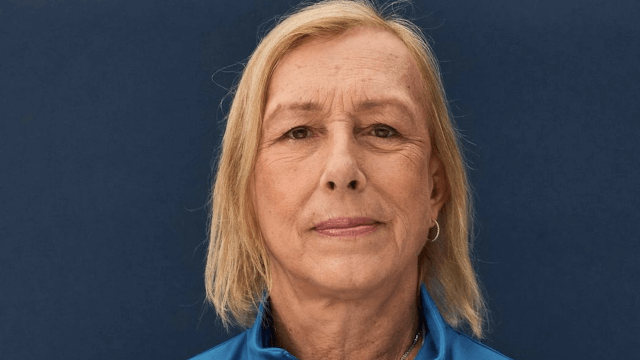«Il genere è un’imitazione: acquisire un genere implica l’imitazione di un ideale a cui nessuno appartiene realmente.»
Chi conosce Judith Butler, lə conosce – e a ben vedere – proprio per il concetto espresso da questa citazione: per le sue sacrosante teorie sulla scivolosità dei generi sessuali e per i suoi ragionamenti legati all’artificiosità delle possibilità di identificazione. Tra lə più contestatə filosofə post-strutturalistə e tra lə più influenti femministə contemporaneə, Butler nasce a Cleveland, nell’Ohio, da una famiglia di origine ebraica. Giovanissimə, dopo gli studi, si specializza a Yale, dove innesta il suo acuto pensiero filosofico-politico nel solco di Hannah Arendt e Michel Foucault, degli ermeneutici tedeschi e di John Austin, il giurista britannico.

Queste ispirazioni variegate sono la riprova di un sincretismo intellettuale e di un eclettismo culturale che, troppo spesso, è stato scambiato per confusione, ma che, a dire il vero, ribadisce la ricchezza di un punto di vista sempre germinale, inesausto e inesauribile, sempre svelto e pronto a coniugare pensiero, parola e azione. Butler è unə filosofə degli interrogativi aperti, un’infaticabilə cercatricə di punti di domanda, che diffida sempre e sempre appare sfiduciatə. Anche di fronte alle risposte piene e alle idee fisse, anche di fronte alle certezze e alle cose incontrovertibili.

Tra queste, su tutte, il sesso e il genere.
Corre l’anno 1990, quando, dopo anni di ricerca indefessa, Butler dà alle stampe Gender Trouble – in Italia Questione di genere (Laterza) –, un volume che, analizzando le opere di Monique Wittig e Simone de Beauvoir, di Sigmund Freud, Julia Kristeva e tanti e tante altre, introduce per la prima volta il tema della performatività del sesso, del genere e della sessualità.
Ogni soggetto desiderante, secondo lə filosofə, non si costruisce nel mondo attraverso scelte autonome, ma come conseguenza di un discorso disciplinare, di un discorso culturale. Così, oltre a criticare efferatamente la vigente cultura patriarcale, il testo entra in opposizione con la tradizione femminista alla quale contesta di aver affrontato il tema del genere, senza decostruirlo davvero e senza destrutturare i termini del binarismo. L’assunto più rivoluzionario del volume, però, sul quale Butler tornerà più e più volte nel corso della sua carriera, è quello che guarda al genere come costrutto di un percorso non solo socio-culturale, ma anche linguistico. È la parola che crea ogni cosa: la parola crea tutto, disciplina ogni cosa, persino i corpi. Il tema viene ripreso qualche anno più tardi in Bodies that matter – Corpi che contano, Castelvecchi – e Undoing Gender – Fare e disfare il genere, Mimesis – che si interrogano sui limiti definitori delle parole sesso e corpo. Cos’è un corpo? Cos’è un sesso? Un dato biologico o un’impronta del potere sociale? E soprattutto: com’è possibile, se è possibile, decostruirli?
È proprio a causa di questo ostinato tentativo di destrutturazione che la voce di Butler è da considerare fondamentale per le istanze che dovrebbero, oggi, soggiacere alle lotte della comunità LGBTQIA+. A questo proposito, lə pensatricə, oltre a costringere a una riflessione anti-binaria e contro-binaria, porta a riflettere intorno alla necessità di ottenere e abbandonare le etichette: definirsi attraverso le categorie esistenti e codificate è importante, anzi fondamentale, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista individuale. Quello che ci si dimentica, spesso, è lo spazio dell’individualità, quello della rivendicazione personale, che – attenzione! – nell’ottica butleriana non ha nulla a che vedere con la rinuncia di una postura socio-politica o comunitaria, ma con l’idea che il corpo sia da intendere come dispositivo libero, capace di attraversare diverse identità.
Nulla è fisso, nulla è binario, tutto può essere conquistato.
Essə stessə queer e non-binary (nel 2020 dichiara che il suo pronome di riferimento è they/them), Butler è da sempre impegnatə nel campo dell’attivismo transfemminista e anti-bellico. Proprio alla guerra e alla violenza, ləi ha dedicato buona parte dei suoi ultimi interventi e dei suoi ultimi testi. Qualche giorno fa, a distanza di poche ore dal riaccendersi della crisi israelo-palestinese, Butler ha dichiarato che “solo una democrazia radicale può mettere fine alla violenza in Medio Oriente”.
Coraggiosə ed ereticə, ecletticə e telluricə, complessə, controversə magicə e radicale, Judith Butler è lə pensatricə di cui abbiamo bisogno.
cover: foto a sinistra da Wikipedia – foto a destra: Judith Butler al CCCB 2018, autore: Miquel Taverna – Fonte: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.