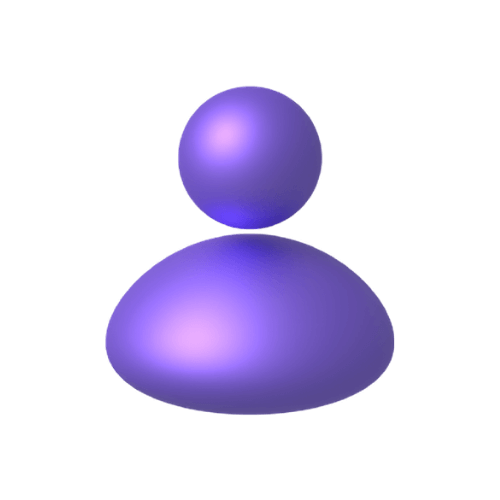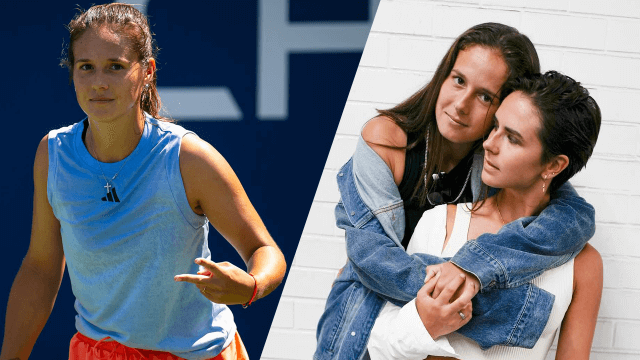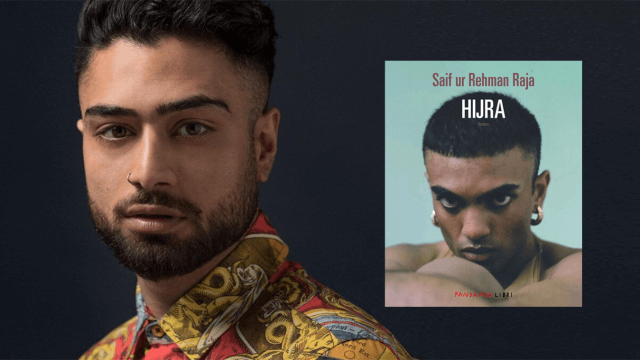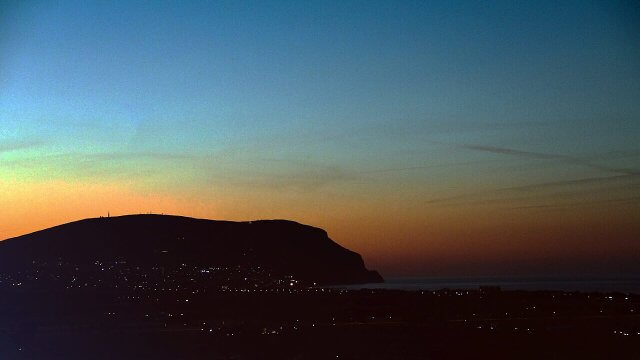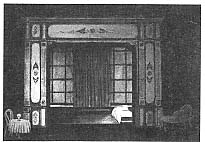
Le favole iniziano di solito in un sontuoso castello, ai bordi di un lago, in un bosco o tutt’al più in una fattoria. Ci sono fate, principi, qualche strega o magari un grillo parlante. E i figli? Sì, anche quelli ci sono: sono il frutto dell’amore fra il re e la regina, dell’incontro furtivo e romantico di due giovani oppure al massimo devono la loro esistenza a qualche scappatella o intrigo di corte. Mai vista una fiaba che inizia in un tabarin, fra entreneuses e camerieri checca, dove una specie di chansonnier, dedito alla prostituzione, s’innamora di un nobile rampollo, va a vivere in un’ala del suo palazzo e, come se tutto ciò non bastasse, decide di avere un figlio. Pensate che una storia del genere non possa esistere? Ritenete che non possa essere una fiaba e come tale magnificamente dolce e commovente? Ma – soprattutto – non vi spiegate come due uomini possano avere un figlio? Vedere per credere. Al Teatro Litta di Milano, fino al 4 giugno, è in scena Saro e la rosa, scritto e interpretato da Francesco Silvestri.
Edoardo, un giovane nobile, s’innamora di Antonio, incontrato appunto in un tabarin, lo accoglie nella propria villa e convive con lui. I due coltivano il loro amore attorniati dall’altera sorella e dalla madre di Edoardo, che, con Frida, giovane serva, spende la propria vecchiaia nel tentativo di far nascere una rosa color del cielo. Ben presto anche i due amanti decidono di coltivare un loro fiore, di far germogliare qualcosa dal loro incontro: da questo desiderio nascerà Saro, che solo a vent’anni scoprirà la verità sulle proprie origini.
Ambientata a Napoli, dagli anni ’20 agli anni’70, la storia può definirsi, a ragione, una favola del ventesimo secolo. Forse perché la poesia non è affidata ad un incantesimo, ma all’amore unico di due uomini, che lo difendono e lo affermano non in un paese lontano lontano, ma qui in Italia. Forse perché al posto dell’orco o di Barbablù sale sulla scena un gerarca fascista, con la volgarità della sua retorica da regime. Forse perché non il bacio di un principe risveglia Edoardo nella notte, ma le attenzioni morbose della sorella che in ogni modo tenta di legarlo a sé. Forse perché alla fine, quando la storia termina, non siamo poi così certi che tutti vissero, come d’uso, felici e contenti. Ma, si sa, anche questo fa parte delle storie del nostro secolo, di noi, che “non siamo fatti per la serenità”, non amiamo più i lieto fine o li amiamo talmente da non poterne accettare il peso.
Tuttavia non è tanto nella conclusione quanto nello svolgimento che risiede la morale di questa favola senza morale, di questa storia oscena e dolcissima dove due uomini trovano la forza di rivendicare una comune paternità: la paternità di un sogno. Edoardo e Antonio costruiscono il loro amore, gli si dedicano come a un fiore da coltivare e quando il fiore oramai è sbocciato il tempo viene meno e si fa tardi, troppo tardi. Nulla è più prossimo, ma tutto è qui, presente, dolorosamente vero. Così l’anziana marchesa lascia le scene accompagnata da Frida stringendo in mano quella che avrebbe dovuto essere la loro rosa color del cielo ed è semplicemente una rosa rossa, così Edoardo verga le ultime righe della sua storia: “e mi avviai verso casa, inghiottendo lacrime felici eppure amare. La favola, la nostra favola d’amore, durata più di vent’anni, stava per raggiungere la sua meritata e radiosa fine”.
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.