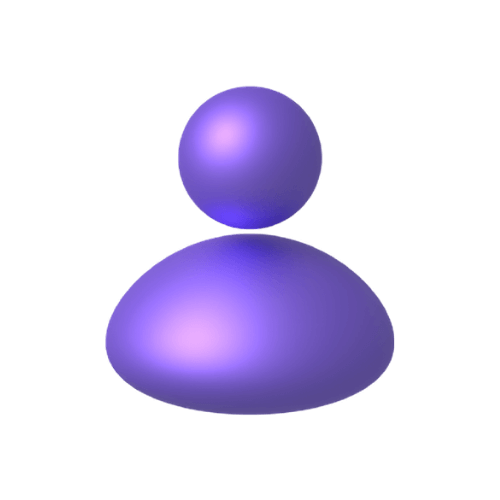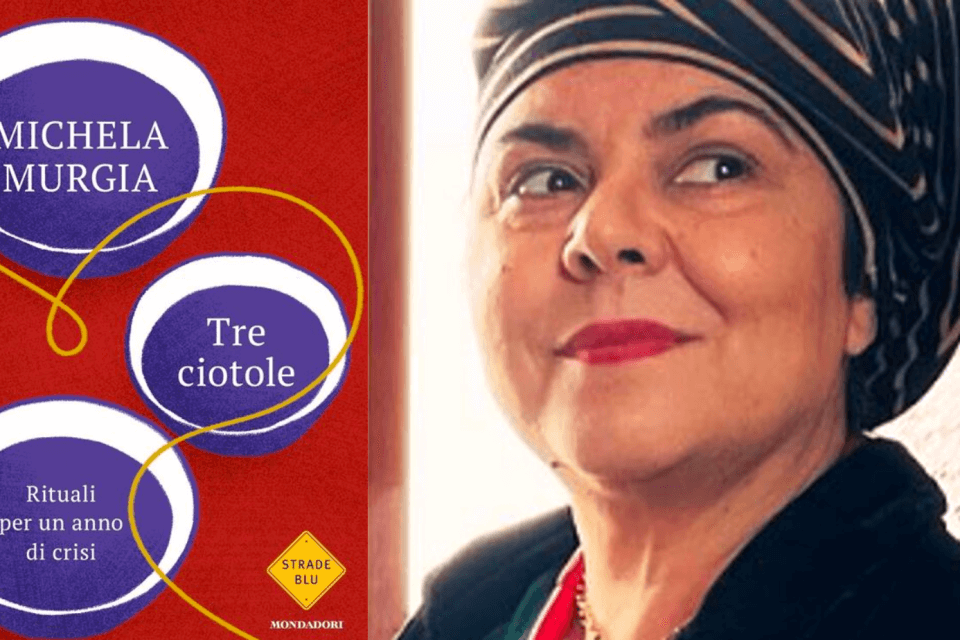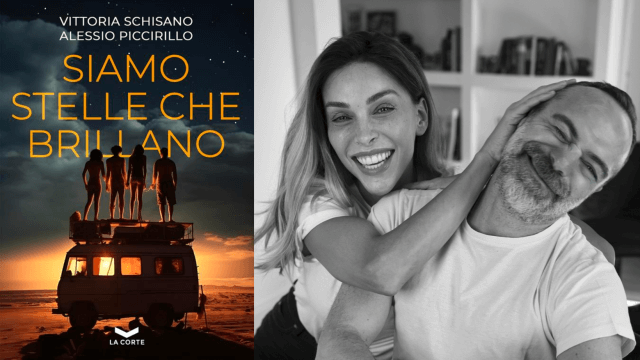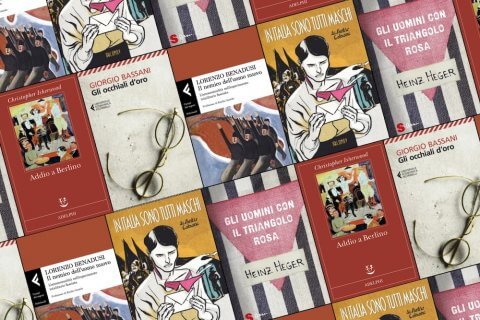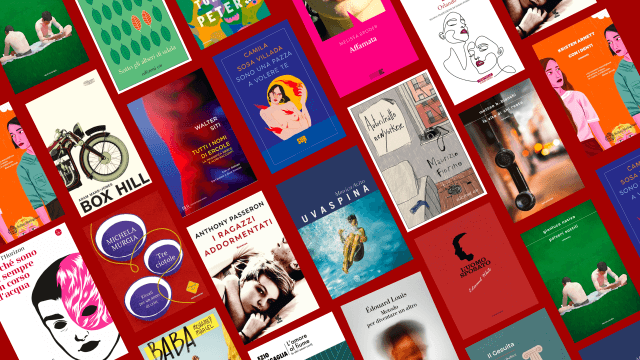Se c’è una cosa, una soltanto se proprio dev’esserci, che la letteratura dovrebbe fare, allora, quella cosa è il ribaltamento dello sguardo. Nonostante sia inutile – almeno su un piano concreto e fattuale – la letteratura serve a cambiare le prospettive. Lo ha detto anche Michela Murgia nella recente intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Un’intervista che è una dichiarazione di intenti, una confessione e un atto politico.
L’abbiamo letta in tantə e in tantə ci siamo commossə e fermatə a ragionare. Così come ora in tantə, tantissimə stiamo leggendo Tre ciotole, il libro che segna per Murgia il ritorno alla narrativa. Certo, la luminosità e la precisione di Accabadora (Einaudi, 2015) sono piuttosto lontani, ma i racconti che compongono Tre ciotole hanno un valore innegabile che attesta, tra l’altro, la credibilità e la coerenza dell’autrice sarda. Cioè ribaltano lo sguardo. Murgia lo fa davvero. Lo fa quasi di proposito e a volte anche didascalicamente (il che, si sa, può non essere un pregio). Quelle contenute nel libro edito Mondadori sono dodici storie che si intrecciano e si completano e tutte insieme si amalgamano in un romanzo aperto, in un testo ibrido, queer a suo modo, che mescola i generi e produce punti di incontro tra fiction, non fiction e self help.
Rituali per un anno di crisi è il sottotitolo della raccolta, un sintagma che arriva dritto dal secondo racconto di Tre ciotole, intitolato Il senso della nausea. La storia di una donna che, vittima del mal d’amore, smette di mangiare. Non tanto per una ripicca dichiarata nei confronti della vita quanto più a causa di una reazione fisiologica al dolore. Soffre, dunque vomita e per non vomitare, per placare la nausea, deve ridefinire le sue abitudini alimentari, stravolgere la sua vita gastronomica e mangiare tre ciotole al giorno. Mangia con le bacchette, senza orari né regole. Si ribella alla prassi, alla tradizione e al costume per ricominciare a vivere, per sopravvivere al dolore o meglio ancora per vivere nel dolore. Nonostante il dolore, insieme al dolore.
In questo racconto – così come anche nel primissimo, che tra tutti è quello è più evidentemente prossimo alla recente esperienza di Murgia – è cristallizzato quello che è il senso complessivo del testo. Raccontare l’umanità nella crisi e le piccole grandi crisi, totali o passeggere, dell’umanità. Gli essere umani come individui complessi e contraddittori, creature nel bardo, sospese sempre tra la vita e la morte. Raccontare le scappatoie al dolore, la ricerca di una via di fuga, di una porta aperta, i meccanismi di compensazione e di sopravvivenza, l’istinto resiliente di fronte al turbamento.
I protagonisti e le protagoniste di questi racconti scoprono la malattia e la perdita, vivono il dolore o se lo autoinfliggono, conoscono la rabbia, il mal d’amore, l’afflizione e l’ossessione. Conoscono lo sbandamento, gli scossoni personali e collettivi, come le guerre, i fascismi e le pandemie. Nel caos, però, esistono dando un nome alle esperienze che vivono, cercando le giuste parole e le consapevolezze adeguate per affrontare i giorni. Così, per fare un esempio, la protagonista del primo racconto scopre di avere un cancro e si affida per comprenderlo e accettarlo alla lingua coreana. È lei stessa, anche di fronte a una malattia incurabile, a scegliere come definire la sua esistenza, quali parole selezionare, da quale lingua estrarle, quale sguardo esercitare sulle proprie esperienze. Così il cancro è un cancro, non un brutto male né un maledetto, non un alieno come lo chiamava Fallaci né una gravidanza demoniaca come lo definiva San Gerolamo. Non viene da fuori, ma da dentro. È in noi, potenzialmente o effettivamente. Non è un nemico, ma quasi un’appendice. E quindi se non esistono nemici, non esistono linguaggi bellici funzionali né guerre effettive. Esiste la comprensione, la consapevolezza, una possibilità di manovra anche di fronte alla certezza della morte.
È qui che avviene il primo rovesciamento dello sguardo, nelle primissime pagine del testo. È qui che Murgia inizia a ridefinire le traiettorie e le prospettive ricorrendo a un gesto letterario luminosamente rivoluzionario, a un comportamento narrativo che sceglie le esperienze personali per raccontare in modo nuovo i temi universali. Tre ciotole commuove perché riguarda tuttə noi, riguarda le nostre vite e quindi anche le nostre morti. Poi ci offre un pensiero consolatorio: c’è sempre un rituale che possiamo abbracciare per dirci vivə nella crisi. C’è sempre una possibilità di resistenza, un patto e dunque una cura. Vivere è approssimarsi alla morte, ma è anche resistere. Tre ciotole in questo è il testo più politico di Murgia, perché racconta l’essere umano in ginocchio, nella sua essenza. Racconta l’intimo e dunque fa esplodere il discorso collettivo e politico. È un libro antifascista e antimilitarista, negli intenti e nei suoi snodi principali. È un libro che ci tiene svegliə e ci ricorda di arrivare sempre vivə alla morte.
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.