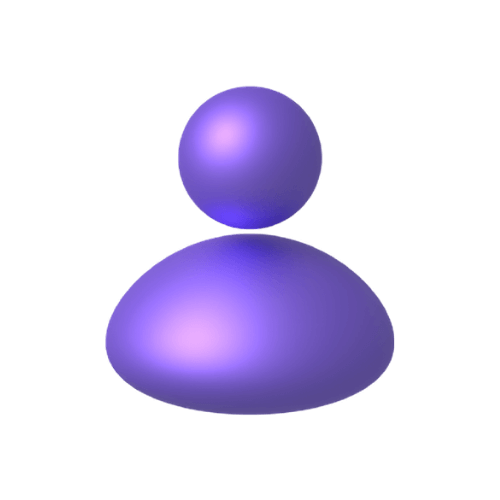“Una storia d’amore tra due persone attratte irresistibilmente l’una dall’altra”. Così l’interessante ma irrisolto ‘The Master’ era stato definito a Venezia dal suo regista, l’ottimo Paul Thomas Anderson, autore di grandi affreschi altmaniani (‘Magnolia’, ‘Boogie Nights’), insoliti thriller crepuscolari (‘Sydney’), epiche saghe d’una certa ruvidezza (‘Il petroliere’). Anche qui torna a raccontare l’anima profonda delle contraddizioni americane, attraverso il complesso rapporto di dominazione psicologica da parte di Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman, superlativo, candidato all’Oscar e ai Golden Globes), capo di una setta emergente, ‘La Causa’ – siamo negli anni Cinquanta, e ogni novità, a partire dalla moda, è accolta con incuriosita partecipazione – nei confronti di Freddie Quell (Joaquin Phoenix, ugualmente strepitoso e candidato anche lui a Oscar e Golden Globes), un marinaio reduce di guerra, disturbato e dipendente dall’alcool.

In effetti è percepibile un sottotesto gay tra i protagonisti – non così evidente, comunque – puramente platonico e ‘di testa’ (l’unica concessione fisica è un giocoso rotolarsi insieme in un giardino), dettato dal rapporto di sudditanza che si fa totalizzante, al punto che Lancaster, per tenere a sé il violento e animalesco Freddie, gli intonerà una canzone d’amore come se fosse una sirena che cerca di convincere il suo Odisseo e lo stesso Freddie, quando finalmente si porterà a letto una donna (il grande rimosso del film, simboleggiato dalla matronale scultura di sabbia sulla spiaggia), le proporrà la stessa terapia verbale utilizzata da Lancaster per elaborare i traumi del passato, come se fra le lenzuola ci fosse proprio l’inseparabile Maestro. Abilissimo, costui, nell’utilizzare le tipiche dinamiche di coercizione psicologica caratteristiche del rapporto master/slave – non prive di un approccio ironico: “Il segreto è la risata”, ripete Dodd – che richiamano una certa cultura underground anche queer (molto contemporanea: non è un caso che, fra Nizza e Berlino, impazzino le serate gay d’impronta sado del ‘mercato degli schiavi’). Se il punto di forza di ‘The Master’ sono le ineccepibili interpretazioni di Hoffman e Phoenix, premiate a Venezia con la Coppa Volpi ex-aequo mentre il film si è aggiudicato il Leone d’Argento per la migliore regia, affiancate dalla brava Amy Adams (doppia candidatura a Oscar e Golden Globes anche per lei) che incarna la figura quasi ancellare dell’apparentemente protettiva first lady della setta, la sospettosa Peggy – vi consigliamo la visione in lingua originale – è invece molto più debole la struttura narrativa, ripetitiva e ridondante, viziata da un ritmo piuttosto affaticato.

Ispirato alla genesi della discussa setta americana Scientology e del suo fondatore, il poliedrico Ron Hubbard, scrittore di fantascienza autore della Bibbia del movimento, la controversa Dianetics (nel film diventa ‘Il libro’), ‘The Master’ in realtà se ne distanzia per tentare di tessere un’ambiziosa metafora dalle atmosfere ipnotiche, a cui dà il proprio contributo la musica minimalista di Jonny Greenwood, sull’inconscio di tenebra dell’America, bisognoso costantemente di un leader spirituale che indichi la via ma non ne sopprima una certa individualità anarcoide, legato alla rassicurante ritualità collettiva, desideroso di comprendere le proprie radici ma ossessionata dall’idea di potere inteso come dominio assoluto sul prossimo. E a tratti proprio questo suo approccio filosofico-sociologico, perfetto per un saggio ma meno per un’arte visivo-sensoriale come il cinema, ne rappresenta il suo limite maggiore.
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.