Ne Il padre d’Italia, l’ultimo film di Fabio Mollo, il protagonista, Paolo (Luca Marinelli), omosessuale poco a suo agio nel mondo, sente di non potersi permettere una famiglia. Invece Mia (Isabella Ragonese), la giovane che Paolo trova all’improvviso sulla sua strada, sta per diventare madre, è incinta, ma non accoglie esattamente con gioia l’imminente lieto evento. La potente storia raccontata dal film mette in scena con gusto e delicatezza il disallineamento tra possibilità biologica e desiderio di maternità/paternità. Il film mette in discussione la retorica del determinismo biologico e relazioni: l’istinto materno e quello paterno, ci mostra il film di Mollo, appartengono alla personalità e alla storia di ognuno. Non al corpo o ai genitali.
La famiglia naturale di Paolo ha prodotto un dramma, è il grande vuoto su cui la vita sospesa del giovane gravita; la figlia che Mia aspetta è arrivata in modo “naturale” ma rischia di non avere una famiglia. Mia è incinta ma non vuole essere madre, non ci riesce. Ha troppa fretta, il mondo la chiama con troppa insistenza. Ma in questo suo rifiuto verso la bambina che ha nella pancia trasmette a Paolo la sensazione che le cose possano andare diversamente, che limiti e confini siano attraversabili, relativi.
La Natura – possibilmente con la N maiuscola – è un grande dispositivo protettivo che i più invocano per mettere a tacere le scomodità del reale. Esprime il nostro primitivo, originario bisogno di controllo, il bisogno di pensare che le cose stiano in un modo, e in uno soltanto. Si dice “contro natura” ma si intende “contro la tradizione”, contro l’abitudine. In questo senso la polarità è tra il bisogno di controllo e l’immaginazione, che è la facoltà di mettersi in contatto col nuovo, con le possibilità altre. L’immaginazione espone all’imprevisto e all’inaudito, porta sulle strade non ancora battute, smuove il terreno, apre passaggi nella trama degli usi e dei costumi. Nel grande e ormai abituale dibattito sulla famiglia e l’omogenitorialità si rileva chiara una tensione. Una tensione che nasce dalla resistenza che lo scenario tradizionale coi suoi sostenitori oppone al nuovo immaginario affettivo e relazionale che preme per emergere, che chiede spazio e legittimazione pubblica. È soprattutto uno scontro tra immaginari. Riguarda l’effetto che le cose ci fanno.
La natura è un limite, la natura fissa dei limiti – sentiamo dire. È bizzarro: perché mai si ritiene che la natura possa essere manipolabile, rinnegabile, dirottabile di fatto quasi sempre tranne che in certi casi specifici, come quello della genitorialità? Tutta la nostra società è fondata sull’intervento attivo e radicale sul dato di natura. La tecnologica, la medicina, la giurisprudenza, la morale… Tutta la civilizzazione e la cultura e il diritto intervengono per rendere possibile qualche cosa d’altro dall’ordine “naturale”. In natura, ad esempio, il forte prevale sul debole. La femmina è presa e violata, i vecchi restano indietro, i deboli sono i primi a essere divorati dai predatori, quel che può succedere succede. La natura non è il regno del giusto, non protegge l’uomo, i suoi legami, la sua dignità. L’appello ai limiti naturali è retorico, vi si ricorre soprattutto per evitare di riconoscere la nostra libertà.
Che la libertà faccia paura non è certo una constatazione originale: i pregiudizi rassicurano, i ruoli delimitano il campo, confortano. Danno l’illusione di una direzione definita. Da A a B. Linea retta. E questo conforto ipnotizza a volte anche chi subisce i pregiudizi. Gli stessi soggetti che vivono sulla propria pelle i condizionamenti e le discriminazioni condividono spesso quegli stessi pregiudizi: li interiorizzano, imparano a pensare a se stessi secondo le categorie e le interpretazioni della maggioranza. È il caso degli omosessuali, ma anche ad esempio delle donne, ostacolate nel loro processo di emancipazione dallo sguardo maschile che loro stesse hanno sedimentato ed è diventato ormai una seconda natura.
Dicevamo che i pregiudizi rassicurano, danno il senso di una direzione lineare. Ma l’amore mica va solo dritto. Devia, curva, torna indietro, scavalca, passa al di sotto. Le femministe contrarie alla gestazione per altri (GPA) di fatto assumono, in questo senso, posizioni antiprogressiste e reazionarie: reagiscono irrigidendosi all’idea di un’apertura di nuove aree delle emozioni, dell’immaginazione. Non si limitano a rifiutare lo sfruttamento economico della donna: allargando il raggio della loro critica esse rifiutano a prescindere di pensare ai nuovi modi in cui la libertà e le relazioni possono mettersi in circolo.
Perché alla fine il punto è che non ci basta affatto “decidere per noi”: abbiamo bisogno di estendere anche agli altri le nostre regole e il nostro bisogno di limiti. Nessuno vuole “farsi i fatti propri”, perché una regola che vale solo per me non risulta abbastanza forte da mettermi al riparo dallo strapiombo della libertà. Per questo vogliamo che tutti facciano come noi, che quella pratica che a noi non interessa o inquieta sia proibita del tutto, che quella scelta sia inaccessibile anche agli altri.
Ma il dogma della famiglia naturale, va detto, è insostenibile. La biologia, l’anatomia cosa mai possono assicurare dal punto di vista morale? La storia e la cronaca ci insegnano forse che la famiglia tradizionale è sicura, buona, integra? Non sembra piuttosto che i due aspetti – biologia e qualità dei legami affettivi – siano indipendenti l’uno dall’altro? Si assiste all’assurda difesa ad oltranza della famiglia naturale perché quello che disperatamente cerchiamo non è il giusto, il buono ma il rassicurante, lo stabile, il certo. Negare spazio al nuovo immaginario affettivo rassicura, mette un limite.
Per questo è il momento di provare a separare pregiudizio e realtà, dogma e vita concreta. Dobbiamo imparare e immaginare e diffondere visioni e orizzonti più credibili e concreti di cosa debba e possa essere la famiglia oggi. Perché fare figli è, non un diritto, ma una possibilità degli esseri umani. E oggi semplicemente le possibilità si sono ampliate, si possono fare figli in modo nuovo, diverso. Usciamo dalle fiabe e dalle leggende arcaiche che ci fagocitano la mente. La natura è anche quella che ci regala il cancro, il predominio della forza maschile su quella femminile, le morti premature. Immaginiamo di più, spezziamo la retorica della paura che ci condiziona. Come dice la selvatica Mia ne Il Padre d’Italia, contro natura può significare anche più bello della natura. I prodigi, i piccoli miracoli – anche in senso laico – avvengono, per antonomasia, contro natura. E non possiamo forse dire lo stesso dell’amore?
Immagine di copertina: Steve Walker
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.

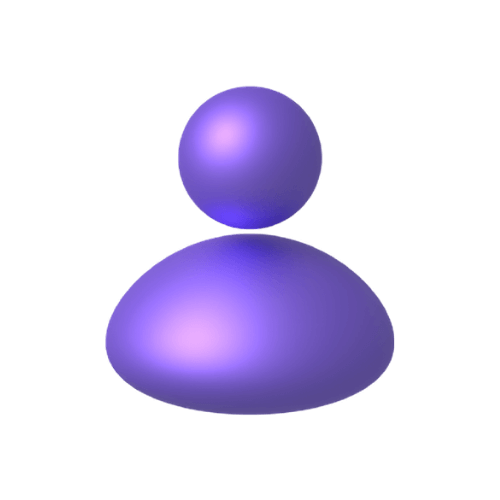
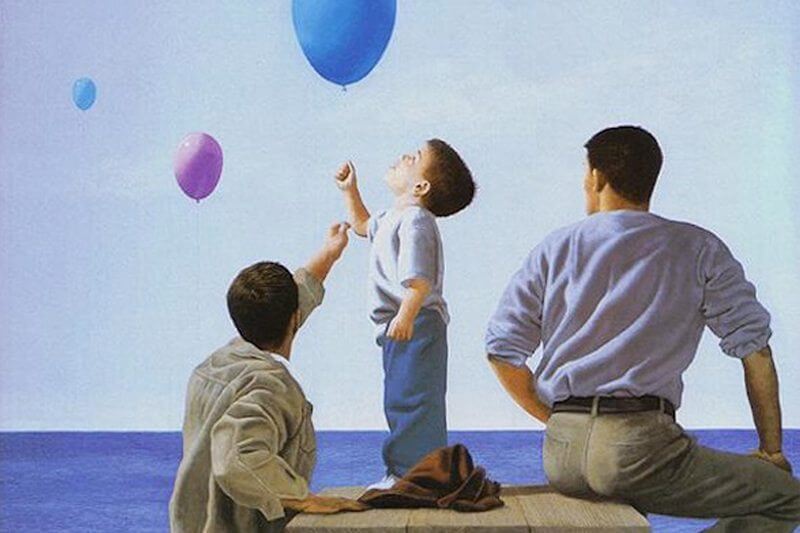












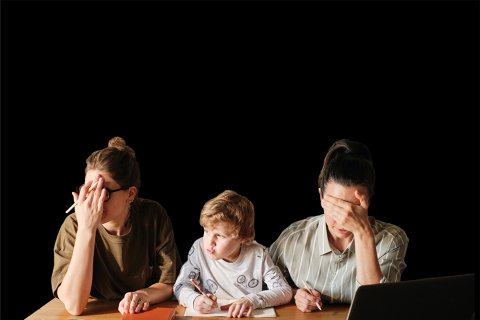

Secondo me l'errore sta anche nel cercare con ossessione l'approvazione da parte degli altri. Negli anni '90 io già convivevo con il mio compagno da molto, sapevo benissimo chi faceva battute, chi commenti, chi se ne fregava e chi mi considerava una persona di qualità (ma non per il mio orientamento sessuale) e chi mi adorava. Ma per me i loro giudizi erano e restano tutti uguali. Non ho certo bisogno che altri mi dicano cosa devo fare della mia vita, chi sono, quanto valgo. Ovviamente avrei potuto dire "ma quella è una analfabeta" o "parla lei che riceve gli universitari a casa la mattina quando c'è il marito e arrotonda" o anche "lui tradisce la moglie con le prostitute che mantiene grazie all'evasione fiscale e sarei io la vergogna della società?". Ma non l'ho mai né detto né pensato: io non giudico, né mi interessa cosa pensano gli altri. Chi ha scritto il pezzo forse è giovane forse non ha mai letto libri classici. Non è che i nostri genitori se la passassero meglio anche se erano etero, l'uomo è sempre pronto a giudicare moralmente, i genitori a rifiutare una nuora o un genero e così via. Ma poi proprio con gli italiani l'ultima cosa da fare è quella di far credere loro che la loro opinione - immancabilmente dall'alto della loro crassa ignoranza provinciale e presunzione globale - abbia non solo qualche minima importanza, ma peso o conseguenza alcuna. Non fatelo mai: 60 milioni di commissari tecnici nazionali, di Papi mancati, di Preti e teologi che dicono alla Chiesa cosa deve o drovrebbe fare (se fare sì il funerale o non farlo), 60 milioni di economisti 60 milioni di filosofi, di musicisti, di critici d'arte, di esperti di tutto e tutti. E voi vi preoccupate pure se vi giudicano?
Mi permetto solo una considerazione. Lei dice: "Ma per me i loro giudizi erano e restano tutti uguali. Non ho certo bisogno che altri mi dicano cosa devo fare della mia vita, chi sono, quanto valgo". Ma lei senza la società che l'ha creata (fisicamente e intellettualmente) non è nulla. Quello che lei vale è un metro che non si è inventato da solo quando aveva 0 anni, la sua morale non se l'è creata da solo ma l'ha acquisita attraverso la società che vive e ha vissuto, il suo senso estetico è in sintonia con questa era ereditata, lei parla una lingua che qualcun altro ha scelto per lei, lei non pensa come un giapponese o un eschimese ma come un europeo. Sostanzialmente, cosa crede ci sia di meritevolmente "suo" in lei? Glie lo chiedo perché date le premesse, per me ovvie, sembra che lei si faccia vanto di ciò che è, ma che in realtà è stato fatto da altri sulla sua persona, come d'altronde su tutti noi. Sbaglio o ho frainteso qualcosa? Avrei anche altre domande.. Perché si preoccupa se la giudicano? Cosa le cambia se lo fanno? Grazie comunque.
Potrei cavarmela citando Margareth Thatcher: "la società non esiste, esistono gli individui". Ovviamente sto parlando per estremizzazioni per far capire che il giudizio degli altri non è così critico come si crede, tantomeno, già che ci sono, quello dei social network cui oggi si dà troppa importanza, e che soprattutto vale più un giudizio che mette in dubbio davvero le mie certezze o una osservazione sensata, una riflessione intelligente - come la Sua per esempio - che miloni di persone, una società, convinte di una serie di stupidate, di cose ridicole o banali. Non è il numero, ma la profondità. Certo che sono anche io il frutto della società, ma sto studiando per disimparare e lo faccio da qualche decina di anni, con le lingue ne ho imparate 4 e sto studiando la quinta.
Completamente d'accordo con te