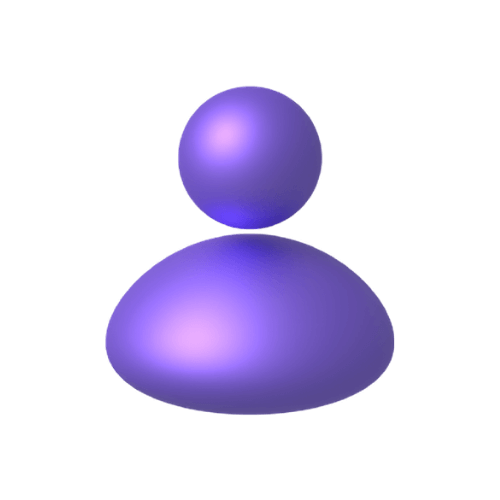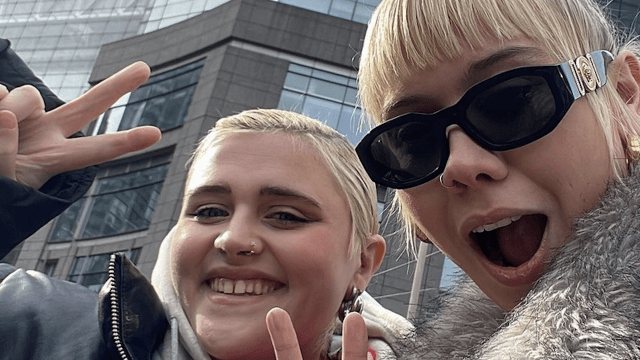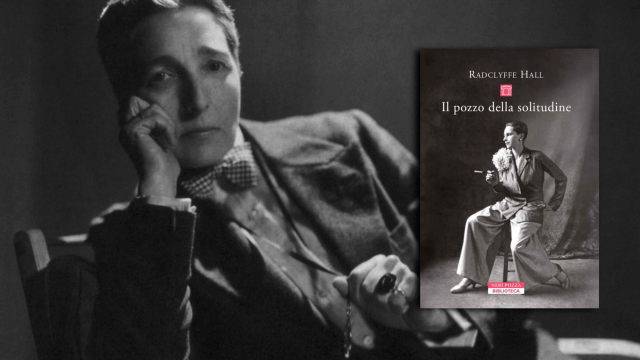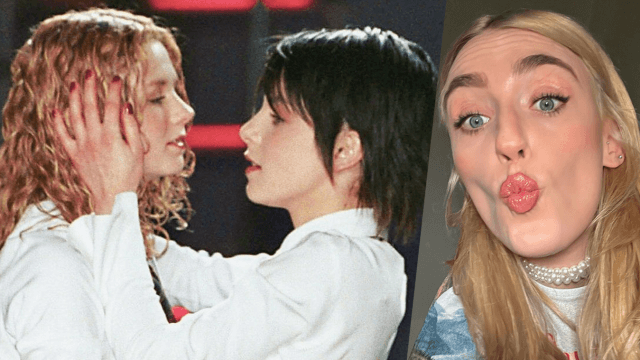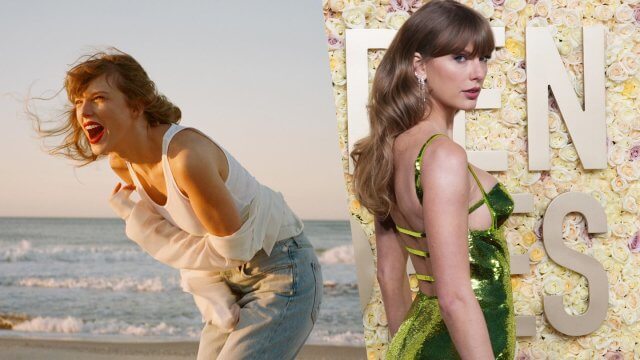L’omosessualità era una fase della crescita del tutto normale per i Greci, quasi un rito di passaggio obbligatorio, ma le poesie di Saffo testimonierebbero un tipo di affettività inedito all’interno dell’educazione femminile.
Saffo è l’unica poetessa dell’antica Grecia di cui oggi abbiamo traccia ad aver testimoniato l’amore tra donne, a dispetto delle innumerevoli testimonianze d’epoca classica di omosessualità maschile, sulla quale si conosce molto di più.
Della poetessa di Lesbo, vissuta fra 600 e 500 a.C., abbiamo poche notizie certe e tante leggende: era un’aristocratica avversa al regime di Pittaco (e per questo fu probabilmente esiliata in Sicilia), sposata e con una figlia. Secondo la tradizione, si suicidò per un rifiuto d’amore dovuto alla sua bruttezza.
Soprattutto però, Saffo insegnò nel tiaso, un vero e proprio mondo a sé, appunto nell’isola di Lesbo, composto da sole ragazze in procinto di sposarsi. In questo posto a tinte edeniche le allieve si dedicavano alla musica, al canto, alla danza, e imparavano la “grazia” che le avrebbe rese desiderabili agli sposi. Ma queste brave ragazze delle classi più agiate si concedevano anche alle compagne in rapporti omosessuali. Fin qui non ci sarebbe da stupirsi in quanto l’omosessualità era considerata dai Greci una fase della crescita che avrebbe consentito ai ragazzi di maturare. Un rito di passaggio a tutti gli effetti, grazie al quale il giovane apprendeva dal più saggio entrando in contatto anche fisico con questo.
Le poesie di Saffo, tuttavia, più che esprimere tale rapporto pedagogico fra allieva e maestra descrivono un vero e proprio innamoramento da parte dell’autrice, che soffre spesso e non accetta la separazione dalle proprie ragazze.
Eros mi scuote l’anima, come il vento che s’infrange sulle querce in cima al monte. (fr. 47 Voigt)
Per Saffo l’amore è una malattia con tutti i suoi sintomi, sia interiori come nel frammento sopra riportato, sia fisici. È celeberrimo il frammento 31, la cosiddetta “Ode alla Gelosia”, in cui la poetessa greca esprime tutta la propria gelosia per un’allieva in probabile compagnia dello sposo. Tale visione fa “scoppiare il cuore in petto” a Saffo:
[…] se ti guardo per un istante, non mi esce un solo filo di voce, ma la lingua mi si spezza e un fuoco scorre esile sotto le membra, la vista mi si annebbia e rombano le orecchie.
Quello che ha riportato la scrittrice nel suo testo più famoso è clinicamente un attacco d’ansia. Se ciò sia dovuto all’invidia per la felicità dello sposo o al fatto che quest’ultimo non sia colto dalla passione come Saffo, non ci è dato saperlo. Ma ciò che più importa è che questo tipo specifico di sofferenza amorosa sia insolito per la poesia tradizionale, non senza un motivo: l’amore vero per i Greci, quello che suscita forti passioni e dà angoscia, è l’amore omosessuale.
Ed è importante che questo sia una donna ad avercelo detto, seppur indirettamente: come suggerisce la storica Eva Cantarella, se sono gli uomini dell’antica Grecia ad insistere esclusivamente sulla funzione istruttiva dell’omosessualità, è stavolta una donna — solo una donna — ad insistere invece sull’affettività e il romanticismo di questi rapporti. Non è una cosa da poco, e questo punto di vista inedito, sul quale la critica si ritrova ancora divisa, svelerebbe che i rapporti fra donne non rispondevano tanto al dovere pedagogico quanto ai sentimenti e, perché no, ai bisogni fisici che delle ragazze potevano risentire segregate in un’isola.
L’omosessualità maschile, alla fine, non era che esaltazione della virilità: «E quanti infine sono parte di maschio danno la caccia al maschio […], e questi sono i migliori fra i fanciulli e i giovani perché sono i più virili di natura. […] Amano ciò che è loro simile» (Platone, Simposio, 192).
La donna, non avendo doti virili, non era dunque considerata un essere completo, né avrebbe potuto raggiungere la perfezione unendosi a un’altra donna. Il punto di vista inedito di Saffo, ancora tanto dibattuto, e studiato — per chi volesse accettare un consiglio di lettura — dalla stessa Eva Cantarella in “L’ambiguo malanno” (Feltrinelli, 2013), aprirebbe allora ad una sfera più intima e affettiva, meno nota, sugli amori pederastici in Grecia. Un ritratto di dolcezza e serenità, reso misterioso e inaccessibile dal tempo, in mezzo a una vita scandita da riti e passaggi obbligatori.
di Marco Nicosia
Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.